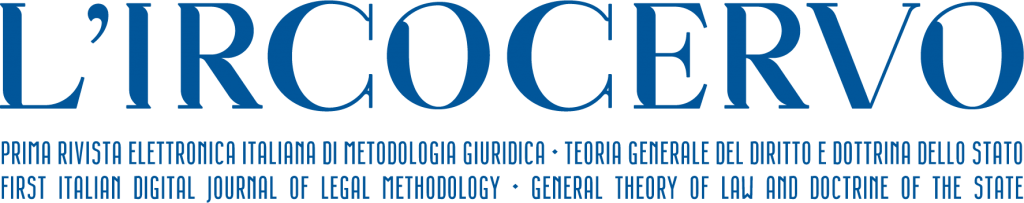AUTONOMIA ED ETERONOMIA
APPUNTI PER UN APPROCCIO ANTROPOLOGICO A PARTIRE
DALLA LEZIONE DI TOMMASO D’AQUINO
di Giovanni Grandi
Università degli Studi di Padova
| Scarica l’articolo > |
Abstract
According to Thomas Aquinas, autonomy and heteronomy are not two opposite ways of understanding moral conscience (as presented by Kant). In an anthropological approach, moral experience is the result of the dialogical structure of conscience with an external law (“heteronomy of the conscience”) and the freedom of the choice, which is also choosing oneself (“autonomy of judgement”). The central problem, then, are not the rules of the conduct to attain happiness, but the order of human desire towards a kind of “god” that is really able to give salvation.
La tensione tra «autonomia» ed «eteronomia» – come ben ricorda l’etimo – riguarda il ruolo del «nomos», della «legge», ma evoca da buon principio il soggetto a cui la legge si rivolge, dunque la persona umana, un soggetto che ha la possibilità del tutto originale di elaborare la legge, di metterla in discussione, di trasgredirla e talvolta persino di abolirla. Siamo, è chiaro, nell’ambito del «morale», che precede e rende sensato il «legale»: la questione dell’autonomia chiama dunque in causa la dimensione interiore o, più comunemente, la «coscienza» e l’esercizio della libertà.
Il dibattito sull’«autonomia» o «eteronomia» della coscienza è forse il più tipico dell’intera riflessione morale, e ruota attorno ad un punto che tutti i grandi pensatori hanno sempre riconosciuto: l’uomo può essere obbligato a fare o non fare qualcosa, ma non a volere o non volere qualcosa. «Con la violenza – scriveva Tommaso d’Aquino – si può impedire che le membra eseguano il comando della volontà. Ma all’atto proprio della volontà [cioè all’adesione interiore che si traduce in un volere] non è possibile fare violenza» .
La pensava in questo modo anche Kant, pur esprimendosi in maniera più faticosa: «L’autonomia della volontà è l’unico principio di ogni legge morale, e dei doveri a questa legge conformi: ogni eteronomia dell’arbitrio, per contro, non solo non fonda alcuna obbligatorietà, ma è anzi contraria al suo principio e alla moralità del dovere» .
L’inviolabilità della coscienza da parte di un qualsiasi potere coercitivo non è una prescrizione morale indirizzata a chi disponga di quel potere, ma è più radicalmente un dato antropologico strutturale. Con questo dato si misura la scienza morale, per lo meno lì dove si pone il problema della maturazione della persona e non insegue il sentiero interrotto della moralizzazione dei comportamenti, un sentiero che appunto si ferma sulla soglia del fare e non ha accesso alle profondità del volere.
Non è un caso che, da questo punto di vista, la prospettiva morale sia molto più
prossima a quella educativa che non a quella giuridica: il discorso moralmente efficace quanto alla formazione non è quello che disciplina i comportamenti sotto minaccia di sanzione, ma quello che conquista l’animo ad una fatica sensata e testimoniata nei suoi esiti umanizzanti. Il discorso moralmente efficace è indubbiamente fatto anche di prescrizioni, di orizzonti non autonomamente messi a fuoco e voluti, a cui indirizzare la persona. Tuttavia, come annotava Maritain, «questa eteronomia non è incompatibile con l’autonomia, poiché l’autonomia dell’agente morale si realizza mediante l’interiorizzazione della legge; questo processo di interiorizzazione è duplice: interiorizzazione mediante l’intelligenza, e interiorizzazione mediante l’amore. La vera autonomia propria dell’essere umano è obbedire ad una legge – la legge di un altro – che egli ha fatto sua con la ragione e con l’amore» .
A voler dunque essere precisi, il cuore della questione non dovrebbe essere tanto il dissidio tra autonomia o eteronomia della coscienza, quanto appunto il tema dell’interiorizzazione della legge e la comprensione della dinamica attraverso cui la
«legge morale» entra in contatto con le profondità del volere e non si estenua lungo il sentiero della disciplina del fare. Tuttavia, anche in vista di una analisi minimale di tutto ciò, la tensione tra «autonomia» ed «eteronomia» merita particolare attenzione.
1. Autonomia della coscienza. Un dibattito che viene da lontano
L’espressione «autonomia della coscienza» va ben intesa nel suo significato. Commentando l’intenso dibattito scaturito a proposito di questo tema nella stagione teologica apertasi con il Concilio Vaticano II, Sergio Bastianel annotava che «in nessun caso, malgrado qualche critica a dir vero strana in questo senso, è dato di intendere l’autonomia morale di cui parlano i teologi contemporanei quasi nel senso di anomia, o di moralità affidata all’arbitrio del singolo o dei gruppi. Il problema, in sede teologica, è quello di vedere se e come il concetto di autonomia sia in grado di render ragione dell’esperienza etica vissuta nella fede» . Siamo nel 1980, e questo accostamento tra «autonomia» ed «arbitrio del singolo o dei gruppi» era individuato chiaramente come un problema con cui misurarsi, un problema capace forse di oscurare quel principio del «primato (pratico) della coscienza» che costituisce l’asse irrinunciabile dell’antropologia cristiana. Scriveva ancora Bastianel: «Un’affermazione classica è quella che assegna alla coscienza l’ultimo giudizio pratico, moralmente vincolante per l’azione. Il principio non poneva problemi fino a che la sua applicazione, con risultati
non conformi alla prassi abitualmente affermata, poteva rivestire un carattere di eccezionalità; ma quando – come in questi ultimi anni – il consenso più o meno comune su molte questioni viene a sfaldarsi frequentemente, il principio stesso può essere tacitamente temuto per le possibili conseguenze pratiche, come pure in vista delle medesime conseguenze pratiche può essere strumentalizzato» .
A distanza di trent’anni, in una condizione di pluralismo sociale e culturale in via di compimento (se non ormai compiuto), si può forse constatare che la previsione è andata decisamente a bersaglio: da un lato si trovano voci che in nome dell’«autonomia della coscienza» tendono a depotenziare il valore oggettivo della legge in campo morale, dall’altro voci che nel riaffermare questo valore si chiedono se non sia il caso di ridimensionare proprio il principio dell’«autonomia della coscienza», ritenendolo alla radice delle derive in senso soggettivistico e relativistico.
Si profilano allora (nuovamente) due visioni di massima, che appunto vengono declinate secondo l’alternativa tra «autonomia» ed «eteronomia» della coscienza. Da qui conviene dunque ripartire. Si tratta anzitutto di provare a comprendere meglio le ragioni dell’una e dell’altra prospettiva partendo proprio dalla situazione culturale attuale e senza trascurare l’incidenza del senso comune nel semantizzare i lemmi in questione («autonomia» ed «eteronomia» in particolare). Poi occorrerà capire se un approccio antropologico alla questione possa contribuire ad una ricomposizione delle due prospettive, accogliendone le legittime preoccupazioni; in particolare qui ci si appoggerà alla lezione di Tommaso d’Aquino isolandone due tesi specifiche, tra loro strettamente collegate, a proposito dell’interiorità, ovvero quella della struttura dialogale della coscienza (che – con le cautele semantiche di cui si dirà – potrà anche implicare una strutturale eteronomia della coscienza) e della strutturale libertà del decidersi (che potrà anche essere espressa come una strutturale autonomia del giudizio). Naturalmente, parlando di «coscienza» e di «giudizio» si parla di un unico soggetto, che è la persona umana.
2. L’«autonomo» e il «non negoziabile». Uno sfondo culturale
Uno dei «peccati» più ricorrenti della riflessione morale è quello che in altri tempi si sarebbe detto di «angelismo»: potremmo tradurlo qui nel non prestare attenzione al senso comune ed al significato culturalmente intuitivo dei concetti. Per quanto sia stimolante riflettere partendo direttamente da Kant, da Tommaso d’Aquino o da Aristotele – o da qualunque altro pensatore di epoche venerabili – non si può pensare di ragionare di «autonomia» senza tener conto di essere nel tempo dei «lavoratori autonomi», degli «autonomi» che indicono scioperi di varia natura che mandano in crisi i trasporti di un Paese, nel tempo in cui gli obiettivi dell’educazione in un qualsiasi Piano di Offerta Formativa puntano a diverse forme di «autonomia», nel tempo in cui la riabilitazione – cioè l’uscita da una condizione di patologia o di infortunio – è espressa nei termini del recupero dell’«autonomia», nel tempo in cui essere «termoautonomi» è preferibile ai costi di un riscaldamento condominiale, nel tempo in cui se qualcuno ci chiede se abbiamo bisogno di un passaggio in macchina ci sentiamo più a nostro agio se possiamo rispondere «no, grazie, sono autonomo».
Essere «autonomi» significa comunemente essere «indipendenti», «liberi» nel senso del poter disporre di sé senza dover adeguare i propri progetti ai tempi, alla disponibilità e alle esigenze di altri. Essere «indipendenti» significa non dover subire imposizioni, non dover agire secondo la volontà altrui, poter fare – si dice anche – «di testa propria». Il «lavoratore autonomo» non a caso ha come compagno di strada il «lavoratore dipendente», ed anche il pensiero morale – se accetta di misurarsi con la cultura, ma potrebbe anche decidere di non farlo, sia chiaro – deve tener conto che tra «autonomia» ed «eteronomia» prendono posto «indipendenza» e «dipendenza», due parole molto più cariche dal punto di vista valutativo, che quasi avvolgono la coppia precedente, contribuendo a semantizzarla.
Il senso culturale diffuso riconosce oggi che il bello del vivere umano si attesta molto di più dalle parti dell’indipendenza/autonomia che non da quelle della dipendenza/eteronomia. È l’idea che la vita sia migliore, abbia più qualità, sia più umana quanto più la persona può far da sé, e che viceversa sia peggiore e più miserevole quanto più la persona deve fare ciò che altri hanno stabilito, e questo – si badi – a