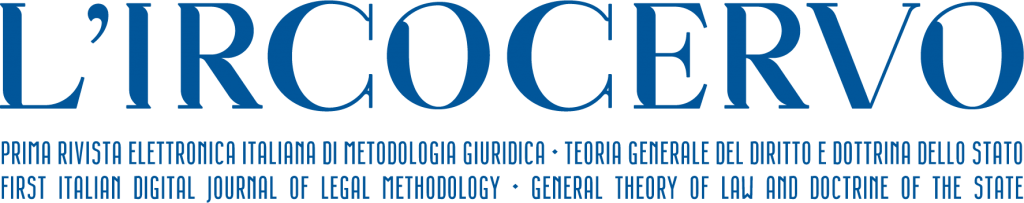LE RAGIONI TEORICHE DEL GIUSTO PROCESSO
di Alberto Berardi [1]
Università degli Studi di Padova
| Scarica l’articolo > |
Abstract
The paper begins by two citations of Vincenzo Manzini and Francesco Gentile that the author uses to present different positions on the role of the process to recognize the truth.
Presenting a natural law position, the Author highlights the false problems of the criminal process, and invites scholars to search in the theoretical roots the starting point to allow the process to become truly the scheme of the legal order and the conflict will turn into a dispute.
Vorrò dar corso a questo breve intervento movendo da due citazioni testuali, che rivestono soggettivamente la caratura di due referenti essenziali ed imprescindibili dei miei interessi giuridici, e che giudico particolarmente fecondi per affrontare la questione problematica sottesa al titolo del mio intervento, e che voglio proporre alla paziente attenzione di chi mi ascolta.
(1) “Il diritto penale non è un diritto di coercizione diretta, bensì di coercizione indiretta (…). La potestà punitiva dello Stato, derivante dalla violazione di una norma giuridica penale, non può essere esercitata senza un accertamento e una dichiarazione giudiziali, che consentano nel caso concreto la punzione” ; [2] ” ; la funzione d’imputazione e di giudizio, in materia penale, ha carattere esclusivo, di giurisdizione obiettiva, finalizzata all’accertamento delle avvenute violazioni del diritto obiettivo, e della conseguente necessaria reazione punitiva; “se, invece, lo Stato acquistasse un diritto ‘subiettivo’ alla repressione, nello stesso momento dell’avvenuta infrazione, bisognerebbe ammettere che nel processo penale lo Stato figuri non solo come parte (il che non è), ma come parte e giudice nel medesimo tempo, ricorrendo ad una funzione tanto fantastica, quanto assurda” .[3] (2) Il processo è lo schema dell’ordinamento giuridico, poiché in esso si compie la trasformazione del conflitto in controversia, vale a dire, in esso, la radicale incomunicabilità che si consolida tra differenti pretese di dominio, capaci di esprimersi esclusivamente in termini di forza, viene convertita nella comunicabilità tra diverse rappresentazioni giuridiche di ordine, la cui disciplina, declinate le pulsioni della forza, s’illumina della ragione del diritto . [4] Il disordine della lite, fatto “di contrasti, di lotte, di rancori, di rivendicazioni, di ripicche, di ostilità, [nel quale] la relazione [intersoggettiva] appare compromessa e comunque interrotta” è destinato, se confinato al di fuori dello schema del processo, a risolversi solo in termini conflittuali, secondo un percorso di affermazione della pretesa di potere, di quel soggetto che le contingenze della violenza e della forza proclamino come vittorioso. Il processo, a contrario, è il luogo della comunicazione, già per il solo fatto di esserci; è il luogo della comunicazione che sovrasta la lacerazione della relazione intersoggettiva prodotta dalla lite, perché il processo è comune alle parti, perché nel processo il giudice è ugualmente comune a tutte le parti in quanto ugualmente distinto da esse, e laddove le parti, tutte, vengano messe, all’interno del processo, “nelle condizioni di poter manifestare la propria visione dell’ordine in relazione ad un conflitto (…), con l’effetto, importantissimo, che tutti coloro che sono destinati a portare il peso dell’esecuzione del risultato del processo, hanno partecipato alla produzione del risultato medesimo” , [5] si compie il prodigio della conversione del conflitto .[6]
Le due letture che ho testé proposto, e che fanno riferimento al vertice dell’insegnamento tecnico-positivo del diritto e della procedura penale di Vincenzo Manzini la prima, e al magistero teoretico del mio maestro Francesco Gentile la seconda, rendono in modo esemplare la cifra teorica di un atteggiamento intellettuale affatto differente ed incompatibile, circa la natura e la funzione d’attribuirsi all’istituto del processo, nel novero polimorfo dell’esperienza giuridica, e quindi della necessità di declinare, in tale contesto, quale sia la cifra teorica maggiormente confacente allo svolgersi del giusto processo .[7] Nella già richiamata prospettiva del positivismo giuridico tecnicista, quella leggibile nelle riflessioni di Manzini, il processo assume il ruolo di una mera procedura di governo dell’estrinsecazione formale del potere punitivo, che è potere e non è diritto ci rammenta Manzini, che è attributo indisponibile della sovranità, che in quanto tale si risolve proceduralmente in una ripartizione di ruoli e di funzioni all’interno della cornice di essa. E quindi lo Stato sovrano non è e non può essere parte e giudice al medesimo tempo – funzione tanto fantastica quanto assurda, chiosa Manzini – e se di un rapporto giuridico può ragionarsi, all’interno del processo, questo non può che risolversi – si badi la finezza intellettuale – in tal guisa: parte del rapporto giuridico processuale è solo l’imputato ; [8] “il giudice evidentemente non è «parte»”, né “il p.m. può qualificarsi «parte» in senso ontologico, giacché esso nulla chiede in proprio nome” ;[9] il rapporto giuridico processuale non si costituisce tra giudice, accusatore e imputato – quali titolari di interessi contrapposti – bensì solo tra quest’ultimo e lo Stato; ed essendo giudice e pubblico ministero due soggetti che non agiscono per il perseguimento di un’utilità propria, bensì esercitano per delega dell’ordinamento una funzione sovrana che è tipica di quest’ultimo , [10] costoro non possono essere definiti come parti: il processo penale è dunque “un processo a parte unica, l’imputato” .[11] Un contesto teorico come quello surriferito determina inevitabilmente a considerare un non problema il problema dei rapporti e delle relazioni ordinamentali tra i soggetti del processo – connotato a ben vedere essenziale del modello teorico del giusto processo –, se non nella prospettiva della mera ripartizione tecnica delle strutture e delle modalità d’esercizio del potere; ripartizione, tuttavia, tanto fantastica quanto assurda, per citare nuovamente Manzini, nella prospettiva dell’unità del potere sovrano e fonte vieppiù di attriti – absit iniuria verbis e solo per citare nuovamente Manzini – tanto fantastici quanto assurdi nello spingere alla competizione sulla primazia, nell’esercizio di tale potere. Non posso non rammentare, a tal proposito, quel memorabile scontro in aula d’udienza, tra P.M. e Presidente del Tribunale, occorso in occasione di un noto processo, sulla titolarità, contesa da entrambi, della rappresentanza dello Stato nel processo , [12] con l’assurdo che lo Stato, per certi versi era altresì rappresentato dall’imputato, e anche dalla parte civile.
A latere tuttavia di queste “scaramucce” nel malinteso universo giurisdizionale del potere sovrano, il problema resta un non problema.
Come un non problema si appalesa il tema del governo della durata del processo, – connotato a ben vedere anch’esso essenziale al modello teorico del giusto processo – afferendo, tale tema, ancora una volta, a quello delle modalità d’esercizio del potere – magari auto-referenzialmente orientato ad un obiettivo di difesa sociale – che può dirsi interessato, a seconda della contingenza cronologica o di destinazione soggettiva del comando che si assume violato, e che innesta l’accertamento processuale, a dilatare o a restringere, nel contingente, i tempi del giudizio; paradigmatica, a questo proposito – e in negativo –, mi appare l’opzione normativa sulla quale è stata costruita la l. 05.12.2005, n. 251, la cd. legge ex Cirielli, che parametra la durata dei tempi di prescrizione del reato sulla condizione soggettiva di recidivo, vale a dire modellando i termini del diritto potestativo, all’estrinsecazione giurisdizionale della pretesa punitiva dello Stato, su delle istanze chiaramente vetero-positiviste di pericolosità sociale.
E alla stessa stregua un non problema diviene quello della necessità di costruire ogni accertamento processuale di penale responsabilità attorno al cànone – antropologico, prim’ancora che probatorio, nuovamente essenziale al modello teorico del giusto processo – della presunzione d’innocenza dell’imputato ; [13] cànone additabile, invero, alla propria invincibile auto-contraddittorietà, se mortificato al mero dinamismo logico formale dei mezzi di prova indiretta ;[14] è sempre Vincenzo Manzini, a tale riguardo, a venirci nuovamente in aiuto; con il processo penale costruito attorno all’obiettivo del corretto sviluppo operativo della pretesa punitiva dello Stato, il principio della presunzione d’innocenza, “goffamente paradossale e irrazionale”, “diretta filiazione della “pseudo-democrazia a tipo francese, superficiale, parolaia e confusionaria in tutto” diviene inammissibile; “basti pensare – prosegue Manzini – ai casi di custodia preventiva (…) e al fatto stesso dell’imputazione. Dato che quest’ultima ha per presupposto sufficienti indizi di reità (…) essa dovrebbe costituire, se mai, una presunzione di colpevolezza. Come ammettere dunque che equivalga invece al suo opposto, cioè a una presunzione di innocenza? (…) Se si presume l’innocenza dell’imputato, chiede il buon senso, perché dunque si procede contro di lui?” .[15] In definitiva, un non problema diviene quello attorno al quale con tanto entusiasmo si è profusa la fatica intellettuale e organizzativa dell’appassionato amico e Collega Marco Pietropolli: “a meno di non seguire un’esasperata concezione giusnaturalistica del diritto” – proprio quella che si prodiga di seguire chi vi parla – “il processo regolato dalla legge non può che essere giusto” , [16] punto, senza necessità – Manzini docet – di eccessi parolai, superficiali e confusionari.
Orbene, la tesi della quale intendo farmi latore è che non è il convenzionalismo legale, ancorché oggi lo stesso risulti, a partire dalle fonti sovra-nazionali, in grado di spiegare il contenuto e gli effetti sulla giuridizione del giusto processo, a fondarne i profili più autentici e più solidi di validità sostantiva, bensì, a sommesso giudizio di chi vi parla, la corretta comprensione delle sue radici teoriche.
Solo se il processo viene pensato quale schema dell’ordinamento giuridico, quale luogo geometrico notevole dell’esperienza giuridica, nel quale si ricompone in termini giuridici, e non di potere, il meccanismo del conflitto, i non-problemi, dei quali si è svolta poc’anzi rassegna, assurgono a questioni problematiche essenziali dell’esperienza giuridica.
A muovere anzitutto dall’esigenza di salvaguardia della terzietà imparziale del giudice, in termini strutturali, che diviene requisito imprescindibile di attribuzione, alla decisione giudiziaria, della funzione di recupero della relazionalità giuridica interrotta dal delitto; il processo, in tale alveo teorico, e la figura soggettiva del giudice che lo incarna – come già riferito –, esigono di essere comuni alle parti in quanto ugualmente distinti da esse ,[17] di talché, in difetto di tale requisito di terzietà imparziale, viene meno la struttura stessa del processo che ne legittima la più alta delle funzioni. Ho usato per ben due volte la dizione “terzietà imparziale” posto che, come correttamente osserva Oreste Dominioni, questa è la dizione del comma 2° dell’art. 111 Cost., che delinea in tal guisa il duplice connotato, di posizione processuale la prima, e ordinamentale la seconda, che fa del Giudice un soggetto non confondibile in alcun modo con qualsivoglia altro soggetto della giurisdizione formale .
[18] E ciò a tacere del fatto che la stessa legge di ord. giud., a giudizio di chi parla, che è tutto fuorché un conoscitore rodato dell’ord. giud., costruisce correttamente sul ruolo di parte del PM, e di terzo imparziale del Giudice, la soggettività ordinamentale di quest’ultimo, come strutturalmente altra rispetto a quella del primo; come se non in tal guisa, può leggersi l’art. 43 l. ord. giud. che costruisce le funzioni e le attribuzioni del Tribunale attorno alla nozione e all’idea di giurisdizione, laddove l’art. 73, per converso, costruisce le attribuzioni generali del PM attorno all’idea della tutela dei diritti dello Stato?
Ed allora – lungi dal porsi come un non problema – anzitutto proprio la separazione strutturale d’ordine ed appartenenza, tra il soggetto della tutela dei diritti dello Stato e il soggetto della giurisdizione, diviene una necessità logica, prim’ancora che il portato di una determinata opzione convenzionale, del processo che sia autenticamente luogo della comunicazione, che sovrasti la lacerazione della relazione intersoggettiva prodotta dalla lite, che sia comune alle parti, mercé un giudice che sia ugualmente comune a tutte le parti in quanto ugualmente distinto da esse.
È nota, a tal proposito, la critica che può essere indirizzata a tale impostazione, allorquando viene evidenziato il rischio in forza del quale il PM che non appartiene all’unitario ordine giudiziario della magistratura ne uscirebbe perciò sollevato – e ciò produrrebbe degli effetti chiaramente negativi – dalla cd. cultura unitaria della giurisdizione, che sarebbe garanzia per i cittadini d’imparzialità dell’ordine giudiziario medesimo, anche nella tutela dei diritti dello Stato.
Pages 1 2