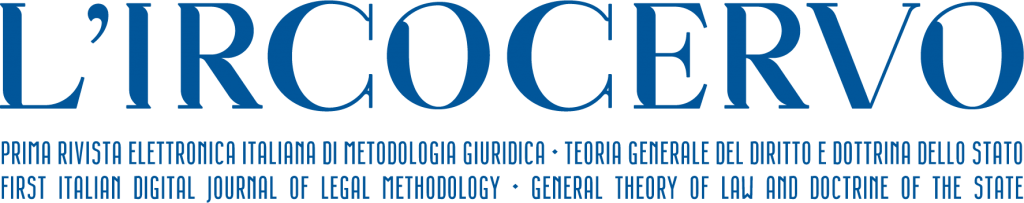Diritto e terrore *
di Gabriele Civello **
| Scarica l’articolo > |
“Gli restano solo due possibilità: o rassegnarsi e smettere di essere se stesso, oppure continuare a coltivare in sé un bisogno interiore di ribellione e manifestarlo di tanto in tanto. Non per cambiare il mondo, come un tempo giustamente e vanamente si augurava Marx, ma perché vi è costretto da un intimo imperativo morale”.
(M. KUNDERA,L’immortalità,V.5)
“La prima condizione per poter fare della metafisica è di vedere veramente il mondo con occhi tali, che esso non si presenti una successione e una serie di assolute ed immediate certezze, ma si presenti tutto come un pullulare di domande e infine esso stesso, nella sua totalità, con tutte le sue parti e sotto tutti i suoi aspetti, come una gigantesca domanda, come un totale ed universale problema”[1].
Con questa icastica asserzione, Marino Gentile tratteggia i contorni essenziali della Metafisica classica, la quale, contrariamente ad altri saperi fondati su una mera giustapposizione di assunti ipotetici, si caratterizza per un procedere ontologicamente e strutturalmente problematico; il Maestro rappresenta tale processo conoscitivo come un “pullulare di domande”, che finisce per sfociare, quasi come un torrente in cascata, in una “gigantesca domanda, come un totale ed universale problema”.
Movendo da tale definizione di Metafisica, non può non emergere la natura essenzialmente metafisica del recente libro di Alberto Berardi, intitolato «Il diritto e il terrore – alle radici teoriche della “finalità di terrorismo”», nel quale l’Autore indaga le radici teoriche e ideologiche del fenomeno terroristico, con attenzione alla disciplina di diritto positivo, ai fondamenti teorici del fenomeno e alle aporie definitorie.
L’opera trova il proprio fulcro strutturale e metodologico nell’individuazione di alcuni profili teorico-problematici, alla ricerca dell’ubi consistam della finalità di terrorismo. In particolare, vengono individuati alcuni approdi classificatori, elaborati da dottrina e giurisprudenza in subiecta materia; in seguito, mediante procedimento confutatorio, vengono enucleate quattro “conclusioni interlocutorie”, ossia quattro approdi conoscitivi provvisori, i quali, pur essendo frutto di un rigoroso percorso argomentativo, sono comunque suscettibili di superamento. Infine, la ricerca termina con una quinta conclusione, “alla ricerca del definitivo”, nella quale si disvela, quasi in un’improvvisa epifania, il “retroterra” antropologico e, al limite, escatologico della categoria del terrorismo.
Dunque, in un’epoca in cui ogni indagine sul fenomeno terroristico è, sovente, incrostata di pregiudizi e stereotipi di matrice ideologica, religiosa e politica, Alberto Berardi dimostra un’opzione metodologica affatto opposta: nella sua opera, infatti, i profili ontologici del terrorismo vengono studiati problematicamente, ossia mediante “depurazione” delle questioni cruciali dai topoi stereotipici che oggi imperversano, soprattutto nell’analisi giornalistica, ma anche in certa dottrina ideologizzata. Con tale approccio, l’Autore fa proprio l’insegnamento secondo il quale “nella prospettiva filosofica, la conoscenza è […] rappresentata dalla metafora del nuotare nella corrente di un fiume, dove il problema è quello di rimettere in ogni momento in discussione la propria posizione e la propria postura al cambio dei flutti e delle correnti, per non andare a fondo”[2]; ne “Il diritto e il terrore”, infatti, la ricerca intorno al fenomeno terroristico si snoda quasi attraverso un arcipelago di problemi e di corrispondenti “risposte provvisorie”, laddove ogni conclusione intermedia ed interlocutoria rappresenta un approdo conoscitivo interinale e, al contempo, un “trampolino” dal quale proseguire la navigazione della conoscenza.
Nella prima parte del testo, l’Autore riporta una sequenza normativa ragionata (la quale, per ragioni di economia espositiva, non è oggetto della presente breve analisi), riguardante gli atti normativi in tema di criminalità politico-sovversiva, dagli anni ‘70 ad oggi, ossia dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), alla l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. “legge Reale” denominata “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”), sino a giungere alla legislazione antiterrorismo più recente, successiva ai fatti dell’11 settembre 2001.
Nella seconda parte del testo, vengono individuati ed analizzati i caratteri fondamentali del terrorismo, i quali emergono dall’analisi normativa e dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: si tratta del ricorso alla violenza efferata e del fine di carattere politico.
Il primo elemento si riferisce al comune uso, da parte dei terroristi, di mezzi cruenti, idonei a creare il panico nella collettività e a provocare grave danno o pericolo per l’incolumità pubblica. Tale rilievo, tuttavia, appare sin da subito affetto da una chiara “insufficienza definitoria”, in quanto è evidente che la violenza non connota esclusivamente il fenomeno terroristico, ma è sostanzialmente comune a numerose dinamiche delittuose, quale, in primis, la criminalità organizzata; quest’ultima, infatti, generalmente, si serve anch’essa di mezzi violenti o intimidatori al fine di stabilire, cristallizzare e mantenere il proprio dominio sul territorio. Ma anche il confronto tra il terrorismo e la c.d. “violenza convenzionale” diviene dubbio, se non imbarazzante, laddove si focalizzi l’attenzione esclusivamente sulla declinazione violenta di tali due fenomeni.
Al fine di cogliere l’essenza del terrorismo, dunque, stante l’insufficienza definitoria del concetto di “violenza efferata”, appare all’Autore necessario abbinare a quest’ultimo il secondo elemento del binomio, ossia il fine eminentemente politico, il quale contraddistingue – recte, sembra contraddistinguere – la finalità terroristica rispetto ad altre finalità criminose estrinsecantisi in episodi di violenza.
Proprio sul profilo ‘politico’, dunque, si concentra l’attenzione dell’Autore, onde comprendere, tra le tante accezioni della politikè téchne, quale sia quella più connaturata alla matrice terroristica.
In proposito, viene in rilievo la nota riflessione in tema di “politica”, la quale principia dalla considerazione della natura “ambigua” di tale termine: infatti, il termine “politica”, che letteralmente significa “della polis”, ossia “della città”, “porta con sé l’ambiguità caratterizzante ogni genitivo, che si lascia intendere indifferentemente nel senso soggettivo, come in quello oggettivo”[3]. Nel senso oggettivo, la “politica” è tutta rivolta “a valle”, ossia concerne i problemi della convivenza comunitaria, in una prospettiva globale e non partigiana, caratterizzata dalla composizione dialettica dei contrasti sociali; nel senso soggettivo, invece, la “politica” indica, “a monte”, tutto ciò che riguarda il soggetto ‘Stato’, quale entità autoreferenziale ed autosufficiente, la quale ha, sostanzialmente, la natura della “parte” che diviene “tutto” mediante un atto di volontà, di potere e, in definitiva, di forza.
Ebbene, è evidente che, trattando del fine ‘politico’ connaturato al terrorismo (o meglio, alla radice iniziale di esso), si fa riferimento ad un’istanza soggettivamente politica, ossia un afflato politico caratterizzato dal trinomio volontà-potere-forza; infatti, non v’è chi non scorga, alla base del fenomeno terroristico, proprio la volontà di sovrapposizione, sopraffazione, dominio di una parte sul tutto (per esempio, storicamente, il dominio del proletariato sulla classe borghese)[4]. E tale approccio sottende, ancor più a monte, un’adesione al paradigma contrattualistico, quale modello teorico nel quale lo Stato moderno viene fondato sulla c.d. “istituzionalizzazione del conflitto”: se, infatti, si fa risalire la fondazione della comunità politica ad un atto di volontà e di forza, tramite il quale alla forza ed alla violenza della moltitudine si sostituiscono, mediante reductio ad unum, la forza e la violenza dell’Uno (ossia, dello Stato), quale modo migliore per rovesciare lo status quo se non quello di sottoporre lo Stato esistente alla sua stessa violenza fondativa, in una spirale ciclica di terrore?
E proprio il riferimento all’istanza “soggettivo-politica” tipica del fenomeno terroristico non può non rinviare al tema schmittiano della “soggettività del nemico”; infatti, proprio la cornice teorica del “conflitto” radicale, tipica del pensiero di Carl Schmitt, pare avere numerose affinità concettuali con la parallela teorica del “terrore permanente”. In tale ottica, “l’aggregazione politica si presenta come aggregazione di conflittualità sin dalla sua definizione, quella definizione che considera la politica secondo la prospettiva unilaterale del conflitto, quale sua unica fonte” (pag. 58).