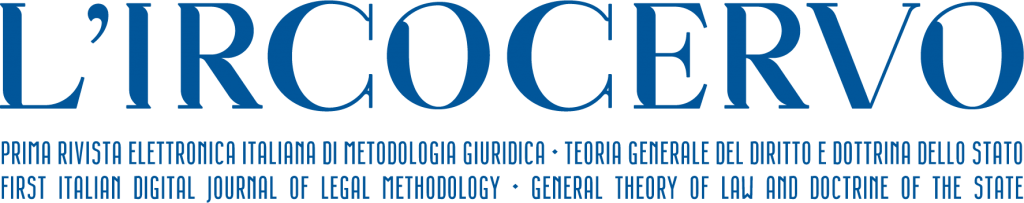Nuova Costituzione:
tra casa comune e dominio delle maggioranze [1]
di Francesco Gentile
| Scarica l’articolo > |
Potendo contare sulla maggior scienza dei colleghi e sulla loro più diretta esperienza, non solo come studiosi del diritto costituzionale ma anche come parlamentari ed uomini di governo, vorrei col mio intervento introduttivo riflettere su tre paradossi che non sfuggono all’attenzione di un qualunque uomo della strada.
Sulla Costituzione italiana, come documento, come Carta, per intendersi quella approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli ( pari all’88% dei votanti) e con 62 contrari (pari al 12 % dei votanti), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 298, ed. str., sono piovute sin dal primo istante della sua entrata in vigore le critiche più diverse e dalle più diverse parti. Alla tentazione non seppero sottrarsi neppure molti Padri Costituenti. In un libretto del 1999, che venne pubblicato dalle Edizioni Scientifiche Italiane nella collana “La Crisalide. Studi filosofici di critica civile”[2], sono raccolte a mo’ d’assaggio una trentina e più di queste critiche. Bocconi dal sapore forte, piccanti per non dire ustionanti. A campione, da una lettera dall’America di Gaetano Salvemini ad Ernesto Rossi: “Ho letto il progetto della nuova costituzione. È una vera alluvione di sciempiaggine. I soli articoli che meriterebbero di essere approvati sono quelli che rendono possibile di emendare o prima o poi quel mostro di bestialità”. Ma qui siamo al primo paradosso!
Per la prima riforma importante della Carta del ’48, in base al disposto dell’art. 138 Cost., bisogna attendere l’ottobre del 2001, con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che rielabora ma meglio sarebbe dire ribalta l’intero Titolo V, quello delle Regioni, delle Provicie e dei Comuni, all’insegna del principio di sussidiarietà; almeno così è detto. E non è che nel frattempo, cinquantatre anni, non si fossero praticati dei tentativi di riforma parlamentare per rimediare a quelli che dalla pubbicistica venivano denunciati come dei “preoccupanti segni d’invecchiamento della Carta, evidenziati in particolare dal processo di unificazione europea e dalle sfide del mercato globale”. La lista di questi tentativi sarebbe lunga e noiosa, dal c.d. “decalogo istituzionale” del II Governo Spadolini, del 1982, ai Comitati di studio che operarono alla fine dell’VIII Legislatura, tra il 1982 e il 1983: Comitato Bonifacio e Comitato Ritz, alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali della IX Legislatura, che prese il nome dall’on. Bozzi ed operò per tutto il 1984. Dal messaggio presidenziale di Francesco Cossiga del luglio, 1991, al tavolo predisposto nel corso della X Legislatura dall’on. Mino Martinazzoli, Ministro per le Riforme, tra il 1991 e il 1992. Dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della XI Legislatura (1992-1994), che prese il nome dall’on. Ciriaco De Mita e dalla Presidente on. Nilde Iotti, alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII Legislatura, del 1997, presieduta dall’on Massimo D’Alema. La citazione degli eponimi rende l’impressione della latitudine delle forze politiche dalle quali i tentativi sono stati posti in essere. Tante critiche, tante, infinite, discussioni, paradossalmente, nessun risultato. Tutti quei tentativi si sono rivelati di fatto delle “tombe” per la riforma a parole invocata. Poiché mi ci sono trovato anch’io, in una di quelle “tombe”, vorrei descrivere in due parole lo stato d’animo che vi ho provato.
Per caso, nel mio si chiamava “pinuccio”, l’estate del 1994, esattamente il 14 luglio, presa di non so quale bastiglia, vengo chiamato a far parte del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 29 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Presidente del Consiglio dei Ministri: on Silvio Berlusconi; Ministro per le Riforme: sen. Francesco Enrico Speroni. L’entusiasmo per la novità dell’inopinato successo elettorale delle tre forze politiche allora costituenti il Polo per le libertà e il buon governo era contagioso. Ne fu preso anche il Comitato, governativo, per le riforme che lavorò freneticamente tutta l’estate, forse per dimostrare d’essere diverso dagli omologhi comitati di matrice parlamentare. Il 21 dicembre 1994, con lettera prot. 988/M/21/12 il Senatore Speroni trasmette al Presidente Berlusconi il testo definitivo del progetto di revisione, costituito da 50 articoli approvati all’unanimità e da due ipotesi di elezione diretta del Capo del Governo, rispettivamente di 18, la proposta Galeotti, e di 6, la proposta Ciaurro, articoli. Scriveva testualmente: “Signor Presidente, ho l’onore di trasmetterLe ufficialmente il testo definitivo del progetto di revisione della Costituzione elaborato dal Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, da Lei nominatoncon decreto del 14 luglio 1994 ai sensi dell’artcolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rassegnare i risultati dell’opera del Comitato da me presieduto, mi sia permesso di esprimere la più viva soddisfazione per il puntuale rispetto del termine del 31 dicembre, da Lei fissato nello stesso decreto istitutivo. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all’impegno costante dei componenti del Comitato, che si sono prodigati in ricerche individuali, studi comparatistici e discussioni collegiali. Il mio personale apprezzamento nei riguardi dei professori membri del Comitato si giustifica altresì per la fermezza dimostrata nel corso della loro attività collegiale, oggeto a volte di pretestuose polemiche, dettate in realtà dalla strumentalizzazione preconcetta di sterili posizioni di scetticismo e di diffidenza verso qualsiasi approfondimento per una migliore organizzazione ed articolazione delle nostre Istituzioni. (..) Relativamente alle proposte riguardanti la forma di governo, mi sia consentito di richiamare la Sua attenzione sul rapporto che viene disegnato tra governo e opposizione, prevedendosi in particolare un vero e proprio ‘statuto dell’opposizione’, quale contrappeso ai maggiori poteri attribuiti all’esecutivo. Inoltre, il testo elaborato riforma in modo sensibile il titolo V della Costituzione, al fine di sviluppare il massimo livello di decentramento a favore di Comuni, Provincie e Regioni. Al riguardo, mi permetto segnalarLe i seguenti punti fondamentali: -il rovesciamento dell’impostazione vigente degli articoli 70 e 117 Cost., nel senso di enumerare in modo tassativo le materie attribuite alla funzione legislativa dello Stato, mentre tutte le altre verrebbero automaticamente affidate alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni; – la garanzia costituzionale per l’autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria degli enti territoriali, secondo il principio della sussidiarietà; l’autonomia finanziaria ed impositiva di Comuni, Provincie e Regioni; -l’abolizione del controllo opreventivo di legittimità sugli atti amministrativi degli enti territoriali. Nel confermarLe che tutti gli aspetti delle singole questioni sono stati esaminati con cura sotto ogni profilo e nell’auspicio di aver così fornito un prezioso contributo per l’avvio del processo di rinnovamento costituzionale, la cui necessità è sempre più avvertita nel Paee, mi è gradità l’occasione di porgerLe i migliori saluto ..”[3].
Vorrei attirare l’attenzione sulla data: 21 dicembre 1994. Se vi si riflette sopra, si può misurare tutta l’ipocrisia, diffusa nell’aria. Si ricorderà, infatti, che il 21 dicembre 1994, in un dibattito drammatico, peraltro spettacolarmente teletrasmesso da Montecitorio al Paese, l’on. Bossi annunciava il ritiro della Lega dal Governo, che rimaneva così privo di maggioranza parlamentare e dunque irrimediabilmente in crisi. Perché parlare di ipocrisia? Ma perché ad un cittadino qualunque, estraneo alle alchimie settarie, risultava, e continua a risultare, difficile capire come possa trovarsi in crisi un governo nel momento in cui ha tra le mani lo strumento per raggiungere quello che, per dichiarazione ufficiale, viene considerato l’obiettivo qualificante il suo programma, ossia “il rinnovamento costituzionale, la cui necessità è sempre più avvertita nel Paese”. Così come appariva, e continua ad apparire, incomprensibile che si potesse dichiarare formalmente l’apprezzamento per il risultato raggiunto, resistendo “alla strumentalizzazione preconcetta di sterili posizioni di scetticismo e di diffidenza” e poi si ritirasse la fiducia. In quella triste sera di dicembre, con l’amara constatazione che la riforma, a parole invocata da tutti, non era argomento determinante e decisivo per la vita di un governo repubblicano, indifferentemente dalla sua collocazione a destra o a sinistra, mi interrogavo, senza trovare risposta, sul perché la via della riforma costituzionale fosse tanto impervia nel nostro paese. Oggi credo di avere la risposta, ma prima è opportuno venire al secondo paradosso che, essendo a noi assai più prossimo, potrà essere assai più rapidamente sondato.
Sul finire della XIII Legislatura (996-2001), come un fulmine a ciel sereno, si fa per dire poiché né di un fulmine si trattava né il cielo era sereno, viene approvata in Parlamento la riforma “epocale” del Titolo V della Costituzione, relativa alla struttura “federale” del sistema politico-amministrativo del paese. Approvata da un Parlamento agli sgoccioli del suo mandato. Approvata con una maggioranza risicatissima: 5 voti. Approvata con un referendum sostanzialmente disertato dagli elettori: 34%. Neppure chi l’aveva votata, la coalizione di centro-sinistra, si nascondeva la precarietà di una simile riforma in limine mortis, costituendo oggettivamente un passo indietro rispetto al processo riformatore messo in atto dalla medesima coalizione di governo, “a costituzione invariata” con la legge c.d. Bassanini, del 15 marzo 1997, n. 59. Il disastro, tuttavia, si doveva rivelare in tutta la sua ampiezza in seguito, con l’ingestibilità di gran parte della riforma, per la mancata metabolizzazione della stessa da parte del sistema, com’è stato messo in evidenza dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 313/2003), che ha dichiarato l’illeggitimità dei regolamenti delle Giunte regionali, mandando in fumo centinaia e centinaia di atti emanati sulla scorta di un leggittimo affidamento. A questo disastro, paradossalmente, oggi, alla fine della XIV Legislatura, con un Parlamento di diverso segno politico ma anch’esso agli sgoccioli del mandato, si pensa di porre rimedio con una riforma della riforma[4], votata nuovamente dalla sola maggioranza, una maggioranza per di più tenuta insieme dal vincolo formale della “fiducia” che, a questo punto, appare soltanto come una “minaccia” ai parlamentari in vista della composizione delle liste per le elezioni incombenti. Il che fa sorgere il sospetto di un uso propagandistico della riforma costituzionale, a destra come a sinistra, del tutto aberrante e scandaloso.
Alla domanda del perché la via della riforma costituzionale sia stata tanto impervia nel nostro paese si unisce così la domanda del perché una riforma finalmente varata debba risultare tanto precaria nel paese da dover essere a sua volta riformata prima di diventare concretamente operativa. Anche a questo proposito ritengo d’avere, oggi, una risposta ma prima è necessaria almeno una battuta sul terzo paradosso.
Da quanto detto si potrebbe dedurre che in Italia nulla sia cambiato dell’assetto costituzionale definito dalla Carta del ’48: cosa del tutto falsa, com’è sotto gli occhi di ognuno. Molti e profondi sono stati i cambiamenti, paradossalmente però non sulla base di una riforma costituzionale ex art. 138 Cost. Se si considerano senza pregiudizi gli eventi, si deve riconoscere che all’origine di ognuno dei più profondi cambia e sulla menti dell’assetto politico repubblicano si trova un referendum popolare. Il referendum sulla preferenza unica del 1991, approvato dal 98% dei votanti, con una partecipazione al voto del 62,5%. Il referendum sul maggioritario del 1993, approvato dall’80% dei votanti, con una partecipazione al voto del 77%. Un movimento che, da un lato, le forze politiche tradizionali non hanno saputo interpretare e governare e che, dall’altro, non si è tradotto correttamente in termini politico-istituzionali ma è stato cavalcato e, a posteriori potremmo dire, snaturato dalla rivoluzione giudiziaria c. d. di Tangentopoli. Le ragioni di Tangentopoli, indiscutibili benché perseguite a senso unico e non a tutto campo, non avevano, infatti, in se valenza politica, in mancanza della quale, erano inevitabilmente destinate a tradursi in un manicheismo intessuto di sfiducia generica ed indifferenziata per la politica. Donde la ricerca delle soluzioni fuori della politica, nell’astratta ingegneria amministrativa o peggio nell’intrigante economia aziendale.
Riflettendo sui tre paradossi si fa strada una risposta, anch’essa paradossale, alle domande sulla difficoltà di perseguire la riforma costituzionale per via parlamentare e sulla precarietà della riforma costituzionale finalmente varata in Parlamento: Perché l’istanza popolare di riforma non ha trovato interpretazione autenticamente politica e perché, detto altrimenti, i politici non hanno saputo dare veste autenticamente istituzionale all’istanza popolare di rinnovamento. Questo è accaduto perché, oggi non avrei molti dubbi a sostenerlo, ai riformatori è mancata una capacità che ha consentito ai costituenti di governare i risentimenti di una guerra civile appena conclusa e di neutralizzare le diffidenze indotte da una guerra mondiale, seppure freddamente, incipiente. Potrà sembrare scandaloso, e certamente verrebbe deprecato da tanti dei “soloni” le cui critiche anche aspre della Carta del ’48 abbiamo visto più sopra raccolte[5], ma è necessario dirlo: Perché è mancata la capacità di compromesso. Mi spiegherò con una citazione tratta da un’intervista concessa dall’allora cardinale Joseph Ratzinger ad Andrea Tornielli e pubblicata sul periodico “Tracce”, nel novembre del 2000.
Pages 1 2