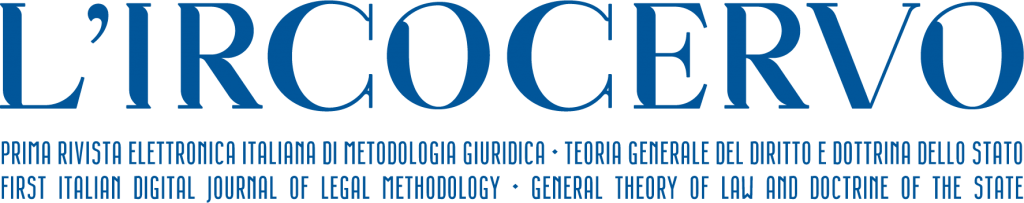LE FICTIONES IURIS
Recensione a F. BRUNETTA d’USSEAUX, Le finzioni del diritto, Giuffrè, 2002, pp. VI—484
di Marco Greggio
| Scarica l’articolo > |
La fictio iuris è sempre stata un tema ficcante per il diritto, a partire dall’esperienza giuridica romana sino ai giorni nostri. Ampiamente utilizzata dal praetor nella creazione del diritto giurisprudenziale, menzionata in famose opere del Trecento/Quattrocento – tra cui il Dictionarum di Alberico da Rosate (m. 1354), il Repertorium di Giovanni Bertachini (seconda metà XV secolo) e il Vocabolario utriusque iuris del Nebrissensis (1442-1522) – e fondamentale nell’evoluzione del common law (secondo Pound, gran parte dell’evoluzione del diritto dei torts fu fondata su fictions), la finzione giuridica, tuttavia, è stata lasciata ai margini nella stagione più gloriosa del formalismo e del positivismo. Lo stesso Kelsen si è occupato di finzione solo incidentalmente, [1] discutendo la famosa opera di Hans Vaihinger [2] (recensita pure da Carl Schmitt). In un’ottica positivistica il problema della fictio iuris non si pone, atteso che esiste soltanto la realtà propriamente forgiata o conformata dal diritto: il sein cede il passo al sollen; conta solo la verità formale assunta in forza di apposite regole procedurali, atte ad ottenere una determinata conseguenza.
La disputa riguardo la natura delle fictiones ha, in realtà, sempre accompagnato la storia della cultura giuridica, ponendo una serie di questioni: già qualche secolo fa, insieme alle dissimulazioni, apparivano come sottospecie della menzogna, scatenando ben immaginabili dispute tra moralisti e realisti. E inoltre, in cosa differisce la fictio iuris rispetto alla simulazione, alla presupposizione, alla presunzione, alle regole di prova legale?
Questo annoso (ma sempre seducente) tema è stato recentemente ripreso in un saggio, pubblicato nel 2002 a cura di Francesca Brunetta d’Usseaux per i tipi della Giuffrè [3] , che raccoglie gli interventi degli autorevoli partecipanti del seminario “Le finzioni del diritto” tenutosi a Genova nel 2001. La profondità di analisi e l’eterogeneità degli autori – civilisti di diritto processuale e sostanziale, giusfilosofi, romanisti, storici del diritto, comparatisti, anche un notaio – offre una lettura in chiave multidisciplinare di questo spinoso tema, affrontato – e questo appare il file rouge dei vari contributi – sempre con chiara coscienza critica, di ampio respiro. Il volume è corredato da una raccolta delle principali fonti che nel corso della storia hanno trattato, esplicitamente o implicitamente, delle varie fictiones, dalla lex de Gallia Cisalpina ai vari codici odierni – le cui norme afferenti al tema sono efficacemente riportate nel loro divenire storico – e da una preziosa raccolta di passi di autori italiani e stranieri citati nel testo (tra gli altri: Guido Alpa, Salvatore Pugliatti, Adriano De Cupis, Riccardo Guastini, Franco Todescan, Rudolph Von Jhering, Chaïm Perelman, Paul Foriers, Olivier Cayla etc.).
Prodromica all’analisi delle finzioni giuridiche, sulla scorta delle varie cifre interpretative offerteci dal saggio, appare una definizione. Specie del genus “finzione” – ossia, secondo Salvatore Pugliatti, il “risultato di un processo mentale che, in quanto immaginato o inventato, non corrisponda puntualmente ad una specifica realtà” [4] – la fictio iuris secondo una prima (ed approssimativa) definizione, è un’interpretazioni “a priori” proposta dal legislatore come modello astratto di riferimento, in previsione del verificarsi di una certa fattispecie concreta. Definizione approssimativa, in quanto un’attenta analisi ci imporrebbe di distinguere almeno tre tipi di fictiones iuris, a seconda del soggetto che le pone in essere: finzioni dei giudici, dei legislatori, degli avvocati.
Lasciando da parte il terzo tipo di fictio, peculiare di un modo particolare di intendere la professione forense (sulla scorta dell’Azzeccagarbugli manzoniano per il quale compito dell’avvocato è quello di “imbrogliare” le cose chiare [5] ), appare particolarmente interessante il primo tipo di finzione, che potremmo definire “giurisprudenziale”, in quanto evidenzia le difficoltà in cui si è imbattuta, e tutt’ora si imbatte, la dogmatica giuridica nel concepire l’ordinamento giuridico, e in modo particolare nel definire il sistema (chiuso) delle fonti del diritto. Difatti, riprendendo la nota analisi proposta da Henry Summer Maine, si potrebbe dire che la finzione giudiziale “consiste nel dissimulare la creazione del diritto, e soddisfare così l’esigenza di riforma senza offendere il tradizionale rispetto d’ispirazione religiosa per l’immutabilità e l’origine divina del diritto” [6] .
Il Maine, nel sostenere la sua tesi, ricorda che in un contesto di evoluzione spontanea del diritto, come esemplarmente nel diritto romano, la fictio aveva soprattutto la funzione di creare nuovo diritto, lasciando immutato quello esistente: nel pieno rispetto, dunque, della tradizione giuridica. [7] Atteso che tutta l’opera di adattamento era di matrice eminentemente giurisprudenziale, la finzione era tipicamente il frutto dell’attività dei giuristi (p. 22), i quali, mediante i loro responsa, se l’equità o l’interesse pubblico esigevano che la parte fosse protetta nonostante non esistesse un’azione volta a farlo, “istruivano” il pretore nel senso che egli giudicasse considerando veri certi fatti che non lo erano (p. 44). Tra i molti esempi possibili, va ricordata la vicenda dei peregrini, che furono considerati come se fossero cives affinché potessero esperire l’actio furti e l’actio legis aquiliae (p. 59); la Lex aquiliae – scarno (ma importantissimo) documento di poche righe risalente al III secolo a.C. – a partire dalla quale il pretore romano, di fronte al progredire di un mondo sempre meno legato all’arcaica società pastorale delle Dodici Tavole, allargava di continuo il damnum iniuria datum, concedendo via via azioni in factum o ficticia “ad exemplum legis Aquiliae” (non diversamente dall’opera della giurisprudenza odierna, che ha esteso, “interpretando”, la portata del 2043 c.c.). [8]
Lo “spettro” del giudice creatore del diritto grazie tramite le fictiones, fonte inammissibile secondo una visione positivista del diritto, fu analizzato anche da Alf Ross (1899-1979). Secondo il giusfilosofo danese, la finzione che contraddistinguerebbe l’esperienza giuridica sarebbe quella – da lui denominata “teoretica” – secondo cui i giudici non creano diritto, mentre in realtà lo fanno e sono coscienti di ciò [9] : sicchè, per “neutralizzare” il problema, egli considerava la finzione giuridica (creativa) come una particolare tecnica per l’estensione analogica delle regole giuridiche. In altri, termini, le finzioni giudiziali sarebbero per Ross finzioni di dettaglio, al servizio della macro-finzione del diritto come entità a sé, non riducibile all’attività dei suoi operatori e ai loro prodotti. [10]
Un secolo e mezzo prima di Ross, Jeremy Bentham (1748-1832) aveva cercato in tutti i modi di ‘esorcizzare’ le finzioni giuridiche (“pestilential breath of fiction”), in quanto esse investivano il giudice di una competenza legislativa che invece non doveva avere [11] : l’unico creatore legittimo del diritto doveva essere il sovrano-legislatore. Su questa linea i giuristi della Scuola dell’esegesi, per i quali, in un ordinamento codificato, le finzioni dovevano ritenersi vietate.
Di parere opposto, invece, Blackstone [12] , secondo il quale in fictione semper subsistit aequitas, e François Geny, per il quale i giuristi non possono fare a meno di elaborare ed utilizzare fictiones, salvo abdicare alla loro funzione, che non può rimanere confinata alla semplice esposizione e/o passiva applicazione del diritto legislativo. [13]
Il dibattito riguardo la funzione creativa del giurista grazie alle fictiones è ripreso nel saggio di cui in commento da Pierluigi Chiassoni, il quale, dopo aver definito le finzioni giudiziali come “discorsi mediante i quali i giudici formulano (…) tipicamente due norme fittizie, l’una regolativi (…) e l’altra interpretativa o costitutiva” (p. 73), si chiede se questa peculiare fictio sia assertiva o normativa. L’Autore opta per la seconda soluzione (pp. 62 e ss.), in quanto la produzione normativa che i giudici realizzano mediante finzioni è, strutturalmente, una nomopoiesi, ossia consisterebbe nella formulazione di una norma nuova, all’interno di una sentenza, in base alla quale il giudice giustifica la particolare decisione assunta; norma che non è necessariamente dotata di forza vincolante erga omnes. Questa nuova regula iuris, tuttavia, sulla base di contingenti norme sulla produzione giuridica, può anche avere, o acquisire, valore di nomotesi, ovvero produrre una norma dotata di forza vincolante erga omnes, in virtù di contingenti precetti sulla produzione giuridica (pp. 70-71).
La raffinata analisi del Chiassoni evidenzia un assunto generalmente condiviso dalla dogmatica giuridica odierna: secondo una cifra ermeneutica fortemente positivistica (tra gli altri, Falzea, cfr. p. 117), le fictiones sarebbero permesse solo nella trama delle leges, restandone precluso l’impiego in sede di interpretatio dottorale o giurisprudenziale. Va rilevato, tuttavia, come il padre putativo della dogmatica contemporanea (perlomeno dal punto di vista della teoria generale del diritto), Kelsen, () escludeva – al pari di Alf Ross – finanche l’esistenza di finzioni legislative. Per il giurista di Praga le fictiones servono a capire la realtà, il mondo dell’essere; il diritto, al contrario, riguarda il dover essere: dunque il divieto di impiego delle finzioni in ambito giuridico è incolmabile, tanto più per i giudici (p. 20). [14] Segue quest’ottica il Fuller, per il quale le finzioni apparterebbero, in particolare, alla “patologia del diritto”. [15]
Questa peculiare visione dell’ordinamento giuridico che porta – forzatamente, pena l’aporia del proprio assunto – a negare l’utilizzabilità delle fictiones è apertamente sconfessata dalla prassi. Difatti le fictiones sono presenti in gran quantità in tutti i “settori” del diritto: civile, amministrativo, costituzionale, processuale, tributario.
Pages 1 2