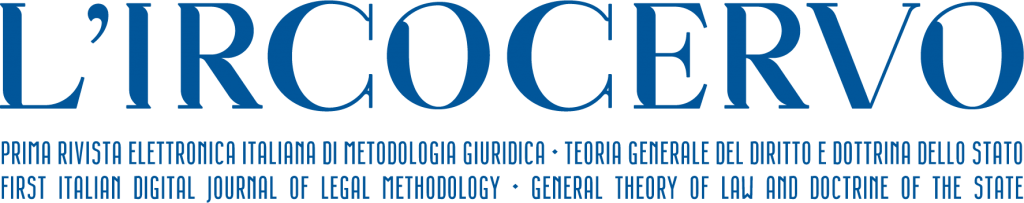SUL GIUSTO GIUDIZIO *
di ELVIO ANCONA
Università degli Studi di Udine
| Scarica l’articolo > |
Abstract
In this paper Elvio Ancona deals with the problem of the just criterion of judgment in trial.
In an age characterized by the increasing importance of jurisdiction in the juridical and political life of our European societies, Ancona suggests by Francesco Gentile to recover the classic (platonic) lesson of dialectic as research of the common among differents and of the different in common.
Il nuovo ruolo della giurisdizione
Uno dei fenomeni più rilevanti dell’universo giuridico contemporaneo è la centralità assunta dalla giurisdizione negli Stati a diritto costituzionale e nello spazio giuridico globale (cfr. M.R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna 2002, pp. 187 ss.; R.H. BORK, Il giudice sovrano, Macerata 2004; J. ALLARD e A. GARAPON, La mondializzazione dei giudici. Nuova rivoluzione del diritto, Macerata 2006; S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma 2009). Non si tratta solo del suo decisivo ruolo nella concretizzazione del diritto e nell’applicazione della legge, già ben evidenziato peraltro dai vari esponenti dell’ermeneutica giuridica (cfr. J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Napoli 1983; G. ZACCARIA, Questioni di interpretazione, Padova 1996). Si tratta piuttosto di una nuova funzione istituzionale svolta dalla magistratura, investita di un compito di “supplenza” nei confronti del legislatore, che si esercita negli spazi lasciati vuoti da una normazione incompleta, contraddittoria, o addirittura inesistente, quale organo di mediazione tra interessi o diritti confliggenti nella soluzione dei casi difficili del nostro tempo. In questa situazione, dunque, il giudice acquista peso e importanza, anche politica, essendo restituito al suo ruolo di dispensatore di giustizia (cfr. ARISTOTELE, Etica Nic., V, 4, 1132 a 20 ss.) piuttosto che di mero esecutore della legge (cfr. MONTESQUIEU, Esprit de loix, XI, 6). La legge infatti non può più essere considerata, nemmeno negli ordinamenti di civil law, il supremo criterio di riferimento nella soluzione delle controversie, dovendosi considerare anche altre fonti, quali la Costituzione, i trattati internazionali e sovranazionali, talvolta perfino la giurisprudenza delle corti superiori (cfr. A. GARAPON, I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, Milano 1997, pp. 25 ss.; S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino 2009, pp. 137 ss.). Si assiste così, specialmente nell’Europa comunitaria, al delinearsi di un nuovo paradigma dell’applicazione del diritto, caratterizzato da un minor formalismo nelle decisioni, ma anche, indubbiamente, da una maggiore incertezza quanto al loro esito. E diventa pertanto inevitabile porsi alcune domande fondamentali. Ci si deve chiedere in particolare: una volta ridimensionato il ruolo della legge, come orientare la discrezionalità e impedire l’arbitrio dei giudici? Come garantire nondimeno un giudizio giusto? Vi sono forse altri criteri da seguire?
Alla ricerca di un criterio per il giudizio
Per rispondere a queste domande conviene fissare la nostra attenzione sul giudizio e cercare se esso possa essere giustificato in base a parametri non arbitrari di giustizia. Appare subito evidente che se il giudizio non può più avere nella sola legge il suo punto di riferimento, esso non può certo nemmeno basarsi sulle opinioni personali del giudice, né, come di recente ha efficacemente mostrato GIORGIO PINO (cfr. Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna 2010, pp. 135 ss.), semplicemente sulla “coscienza sociale” dalla comunità. Se non altro perché in società complesse, non omogenee e profondamente pluraliste come quelle contemporanee, può essere estremamente difficile rinvenire criteri univoci di valutazione.
La risposta della tradizione classica
Dove reperire allora quella giustificazione?
La tradizione classica viene a questo punto in nostro aiuto. Concepita in un’epoca in cui la legge positiva non aveva certo quella predominanza che ha acquisito nella modernità, essa, soprattutto nella sua variante aristotelica, ci richiama una fondamentale caratteristica che il giudizio deve avere se vuole essere giusto. «Si trova necessariamente in una condizione migliore per giudicare colui che ha ascoltato le ragioni opposte, come in un processo» affermava il filosofo greco introducendo la trattazione delle aporie nel terzo libro della Metafisica (B1, 995b2-4). Per ben giudicare, dunque, ci dice ARISTOTELE – occorre considerare gli argomenti di entrambe le parti, il punto di vista dell’uno e dell’altro. Questa apertura alle ragioni dell’altro non va però intesa solo nel senso di quel “pensare mettendosi al posto degli altri” in cui kantianamente consiste la condizione per un autentico distacco dai propri interessi immediati e preferenze private, la condizione quindi per un giudizio veramente imparziale (cfr. I. KANT, Critica del giudizio, §40). L’apertura alle ragioni dell’altro ci consente altresì di riconoscere più facilmente, valorizzandone il peculiare punto di vista, ciò che gli è proprio, quel suum che, secondo la massima di attribuzione ulpianea (cfr. HULPIANUS, Regulae, I, in Dig., 1, 1, 10), gli è giustamente dovuto.
Ma neppure questo basta per giudicare secondo giustizia: resta infatti ancora aperto il problema del criterio della decisione. Proviamo a risolverlo considerando ora, sempre per restare nell’ambito della tradizione classica, un suggerimento “platonizzante” di Francesco Gentile.
L’intuizione platonizzante di Francesco Gentile
Gentile faceva notare che si può riconoscere ciò che è proprio delle parti in causa solo in riferimento a ciò che hanno in comune. Dopo aver rilevato infatti che «per rivendicare ciò che ci spetta, occorre avere di fronte un altro che è necessario però preliminarmente riconoscere come diverso» e che «quando qualcuno rivendica che qualche cosa gli sia dovuta, in realtà non richiede se non il riconoscimento del suo essere “altro” e “diverso” dagli altri», egli d’altra parte aggiungeva che «la diversità può essere predicata solo in relazione a qualche cosa che sia anche “comune”. Il riconoscimento dell’“alterità” porta pertanto alla “diversità”, il cui concetto impone il riconoscimento del “comune”. La rivendicazione di essere rispettati in ciò che è “proprio” richiede logicamente ed essenzialmente come preliminare la presa di coscienza del “comune”» (F. GENTILE, Filosofia del diritto, Padova 2006, p. 147). E’ così possibile stabilire ciò che è dovuto a ciascuno, determinandolo dialetticamente per comunanza e differenza rispetto alle altre spettanze.
Infatti, – ci ricorda Gentile – secondo l’insegnamento del Politico (285 a-b) di PLATONE la dialettica è proprio l’arte di riconoscere il comune tra i diversi e il diverso nel comune. Ed è in quanto sostenuto da una dialettica così concepita, intessuta dall’intrecciarsi del comune e del diverso, che il giudizio è in grado di compiere l’opera propria della giustizia, il suum cuique tribuere.
Due osservazioni si impongono al riguardo:
-il comune in questa prospettiva non è un apriori, un predefinito, un elemento dato una volta per tutte, che si tratta solo di riconoscere e applicare, ma ciò che gradualmente accomuna, il termine di una ricerca, il cui punto di arrivo può essere identificato nella “natura personale dell’uomo” (GENTILE, ibid.), ma non può essere conosciuto che progressivamente e mai del tutto compreso;
-in questa ricerca anche la legge gioca un ruolo, sia le leggi positive che le leggi naturali, senza peraltro che alcuna possa in qualsiasi modo esaurire il comune.
La virtuosità del giudicare
Ma vi è un altro aspetto della concezione classica del giudizio che Gentile ha opportunamente sottolineato: la sua virtuosità. Il giudizio, infatti, per essere giusto, deve essere esercitato da un soggetto che possiede l’abito della giustizia (cfr. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., pp. 145 ss.), abito che – come ci insegna ancora il grande ARISTOTELE (cfr. Etica Nic., V, 1, 1129 b 26 ss.) – consiste proprio nella corretta relazione con gli altri. Possiamo allora comprendere che quando parliamo di dialettica quale metodo del “ben giudicare” non dobbiamo intendere appena una tecnica, ma una virtù: la virtù di considerare il problema da diversi punti di vista, di valorizzare il punto di vista dell’altro. È questo “rispetto”, questa attenzione alle ragioni dell’uno e dell’altro nella ricerca di ciò che è comune, che consente di passare, questa volta con PLATONE (cfr. Repubblica, VII, 533 ss.), dall’opinione al sapere, attingendo i criteri per risolvere la controversia.
Solo così, ricompreso nel suo significato classico, e giustificato dal suo procedere dialettico, mi sembra che il giudizio possa costituire un’autentica bussola di giustizia per la giurisdizione, anche nell’odierna Europa del diritto comunitario.
————————
* Comunicazione presentata al XLIX Convegno Internazionale dell’Institut International d’Études Européennes “A. Rosmini” di Bolzano “Quante giurisdizioni, quale giustizia nell’Europa? (Bolzano, 6-8. ottobre 2010)