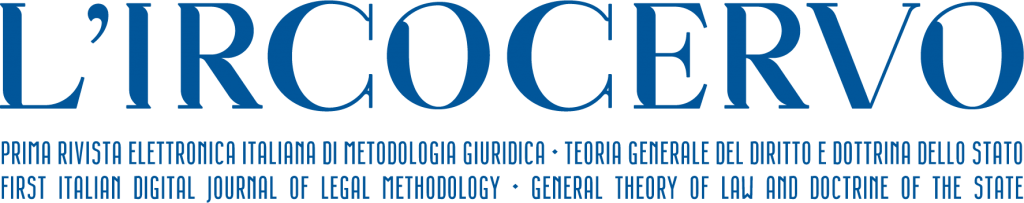DIRITTO E LIBERTÀ*
di Ottavio de Bertolis (Pontificia Università Gregoriana – Roma)
| Scarica l’articolo > |
Abstract
Dealing with the theme of the relation between law and liberty, the Author means to show that law represents the presupposition and not the opponent of liberty. The first view is the Aquinas’ one; the second (beginning from Hobbes) deeply characterizes the modern thought. Through a correct comprehension of the relation between ius and lex, the Author encourages the return to the first view, which is able to assure the primate of man as subject of rights inside the juridical order.
Questa riflessione vuole prendere l’avvio da un’affermazione di Papa Benedetto XVI in un discorso inviato all’Università romana «La Sapienza» il 17 gennaio 2008 . [1] Nel porsi il problema «della relazione tra prassi e teoria, tra conoscenza e agire nella Facoltà di giurisprudenza» il Pontefice sottolinea che questo implica il «dare giusta forma alla libertà umana, che è sempre libertà nella comunione reciproca: il diritto è il presupposto della libertà, non il suo antagonista» . [2] Come la libertà umana può essere indirizzata e guidata alla comunione, quando è evidente che può esserlo anche verso la divisione? Come è possibile conciliare il diritto con la libertà, dal momento che la legge, che è necessariamente coazione, sembrerebbe appunto il suo contrario? Come creare un ordinamento giuridico che rispetti le libertà dei singoli senza votare alla disgregazione il corpo sociale?
Si tratta di problemi che sembrano costituire una sorta di quadratura del cerchio, un’operazione impossibile, un disperato tentativo di conciliare termini opposti, quando non contraddittori, come l’individuo e il gruppo sociale, il privato ed il pubblico, la libertà e il potere. Ancora, è chiaro che questi stessi termini, come «libertà», «diritto» o «legge», sono controversi: possono essere intesi in significati molto diversi, e alcuni di questi sono effettivamente inconciliabili in un discorso unitario. Siamo costretti a muoverci in sentieri caotici, seminascosti e a volte aggrovigliati: alcuni di questi sentieri sono quasi cancellati da una sorta di rimozione culturale , [3] altri sono semplicemente inconsueti. Tutto questo richiede un’attenzione e una disponibilità all’esercizio della ragione in modo privo di tesi precostituite o date per dimostrate: in altri termini, una grande capacità di ascolto, e questo pare abbastanza raro. I «dialoganti» di professione molto facilmente dialogano solo con chi la pensa come loro, proprio come la vicenda della mancata visita del Papa alla Sapienza ha dimostrato una volta di più. Al contrario, la riflessione del Pontefice è un esempio significativo di che cosa voglia dire ragionare sul diritto, cioè sul porsi la domanda del trovare una «forma ragionevole» di esso: in fondo, un’antropologia.
Tempo della libertà e tempo del diritto
Dobbiamo partire da lontano, e cioè da T. Hobbes, il filosofo inglese che meglio esprime le caratteristiche della moderna concezione dello Stato e del diritto. E’ noto che nel suo ragionamento prima dell’istituzione dello Stato attraverso il contratto sociale c’è una situazione invivibile. In quel tempo infatti, ossia nello stato pre-sociale, ognuno è libero di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della propria vita, e conseguentemente di fare ciò che è più idoneo a questo fine . [4] Da questo deriva la ben nota situazione iniziale, o stato, di guerra di tutti contro tutti, il bellum omnium contra omnes. Soltanto l’istituzione dello Stato, mediante la quale tutti rinunciano a quella originaria libertà rimettendola ad un sovrano, singolo o assemblea, mediante un patto fiduciario o trust, può salvare da questa lotta selvaggia, la legge della giungla, che altrimenti dominerebbe le relazioni umane. Possiamo dire che solo la volontà del sovrano, cioè le leggi, crea quelle invisibili catene attraverso le quali una folla di individui, concepiti come rivali , [5] viene ammansita in un’individualità sociale ricomposta nella pace, a prezzo tuttavia del sacrificio della libertà originaria di ognuno, una sorta di laico “peccato originale”: rinuncio alla mia libertà per vivere sicuro . [6]
Qui la redenzione, tutta umana, che consiste nella promessa della sicurezza, crea, costituisce e mantiene la non libertà, ponendo le leggi e l’artificialità dello Stato, ma garantisce in compenso la vita terrena.
Ne deriva una visione della libertà in un senso tutto particolare, ossia in chiave individualistica. Infatti, annota il filosofo inglese: “Secondo il significato proprio del termine si intende per libertà l’assenza di impedimenti esterni. Questi impedimenti possono frequentemente diminuire il potere posseduto da una persona per fare ciò che vorrebbe, ma non possono impedirle di usare il potere che le è rimasto nei modi che il suoi giudizio e la sua ragione le detteranno” .[7] La libertà si risolve nel rispettare il più possibile l’individuo e nel rinchiuderlo il più possibile all’interno del proprio guscio. Questa concezione della libertà è eminentemente negativa, e non positiva come quella prospettata dai medievali, per i quali certo era necessario che la libertà si declinasse a partire dall’assenza di impedimenti esterni, ma al tempo stesso si potesse proiettare, quasi riempendosi di contenuti, alla ricerca del bene oggettivo: così “l’uomo veramente libero era colui che, servendosi dell’assenza di costrizioni esteriori, si orientava alla ricerca della verità etica” .[8] Questo orizzonte oggettivo ed etico scolora nel pensiero moderno, mentre si carica di significati sempre più soggettivi: la mia libertà, il mio bene, la mia verità, concepiti in modo sempre più assoluto, cioè sciolti dalla tua libertà, dal tuo bene, dalla tua verità. Dal soggettivismo nasce la vocazione totalizzante (o totalitaria) dei moderni ordinamenti giuridici.
Prosegue Hobbes, “dalla legge di natura, che ci obbliga a trasferire ad altri quei diritti che, se mantenuti, sono d’impedimento alla pace dell’umanità, ne segue una terza [legge]; che è questa: gli uomini debbono mantenere i patti che hanno fatto. […] In questa legge di natura consiste la fonte e l’origine della giustizia” . [9] Ma in tal modo la legge può assumere qualsiasi contenuto e diventa pura forma: il positivismo giuridico, ossia l’istanza filosofica per la quale è “diritto” solo la “legge” posta dal sovrano, ed i due termini sono ormai assolutamente equivalenti , [10] è inestricabilmente legato al formalismo. E’ legge ciò che ha la forma di essa, ossia che viene approvata con quei procedimenti che fanno di una proposizione qualsiasi una proposizione normativa: se da qui nasce il moderno parlamentarismo, la legittimazione teorica cioè della rappresentanza politica all’interno di un’assemblea sovrana, chiave di volta delle democrazie attuali, non possiamo non notare che questo vantaggio fu conquistato solo facendo coincidere la legge con la volontà di qualcuno. Nasce la “teoria pura del diritto” come definita da H. Kelsen nel secolo scorso, pura perché priva di contaminazioni contenutistiche: il diritto, inteso come legge, è pura forma. Forma della volontà, cioè del potere, e non specchio del mondo (delle cose, della natura) come era invece l’antica iuris dictio . [11] Al contrario, secondo la nostra prospettiva, “la teoria politica non può essere una teoria del potere, ma una teoria dell’autorità legittima” : [12] ” : con questo, intendiamo dire che “riconosciamo il potere solo quando si riferisce ad un senso cui noi aderiamo” .[13] Nell’accezione kelseniana invece, che è quella moderna e comunemente accettata, il diritto, che coincide così con la legge, non è affatto il presupposto della libertà, ma il suo antagonista: nasce infatti dalla rinuncia di quel potere illimitato proprio dello stato di natura. La legge lega la mia libertà, ma solo così rimango vivo, perché sono sottratto all’inevitabile dominio del più forte di me: a pena però che mi sottoponga volontariamente al dominio del più forte di tutti, lo Stato. Siamo dunque in una prospettiva antinomica a quella suggerita dal Pontefice: egli ci invita invece a ripensare il diritto in termini “amichevoli”, o, veramente, “miti”. Si può ragionevolmente pensare, sembra suggerirci il Papa, che il diritto nasca altrove. La ricerca di questo “altrove” segna il passaggio da un diritto antagonista ad una legge amica dell’uomo, che dia appunto giusta forma alla libertà intesa come comunione: è chiaro infatti che nella libertà come prospettata da Hobbes non c’è proprio nulla di comunionale, esprimendo essa al contrario il massimo dell’individualismo. E non a caso, in una lucidissima analisi, Marx denunciò i diritti dell’uomo e del cittadino, enunciati dalla notissima Dichiarazione francese del 1791, e consacrati dal Code successivo [1804], come “il diritto dell’uomo egoista, isolato dal suo simile e dalla comunità” : [14] la libertà di cui ivi si parla è “la libertà dell’uomo in quanto monade isolata e ripiegata su se stessa […]; non si basa sul legame dell’uomo con l’uomo, ma piuttosto sull’isolamento dell’uomo dall’uomo” .[15] “Quella libertà individuale […] lascia che ogni uomo trovi nell’altro uomo non già la realizzazione, ma piuttosto il limite della sua libertà” .[16] Possiamo pensare il diritto in altro modo, ossia come forma del vivere comune (quella “giusta forma alla libertà umana”, della quale parla Benedetto XVI), e non semplicemente insieme, per lo meno nel senso debole di “giustapposti”? Infatti se partiamo da un’antropologia, quale quella occidentale, della primazia dell’individuo concepito come soggetto “pieno” di diritti e caratterizzato da una capacità totalmente espansiva, in cui ogni uomo incarna l’umanità intera ed è la misura di ogni cosa, i fini della società coincidono con i fini legittimi di ogni uomo. In tal modo la società diventa il mezzo, e il diritto di ciascuno il fine: ma in tal modo la società ontologicamente non esiste più e rimane solamente un dato di fatto al quale si chiede di non opporsi alle nostre pretese-diritti . [17] Ma a che cosa ci ricondurrebbe questo nuovo sforzo mentale? E quali nuovi presupposti dovrebbe avere? Ecco la riflessione successiva.
Il diritto come limite: la legge come forma
Il pensiero giuridico classico, a partire dalla fondamentale esperienza romana fino al suo riuso dopo la riscoperta del Digesto verso la fine dell’undicesimo secolo , [18] continuato poi ininterrotto fino alle Codificazioni napoleoniche, conosce invece la distinzione, per noi al contrario desueta, tra diritto e legge cui abbiamo già accennato in una precedente nota: in particolare, il rapporto tra i due è quello dell’antecedente e del conseguente, dell’originario e del derivato, tra la fattispecie da regolare e la regola della fattispecie. Non è un gioco di parole: in questa prospettiva, si ritiene che qualunque situazione umana rilevante abbia già una regola in sé stessa, una grammatica, almeno fondamentalmente, e che questa regola (oggettiva e indipendente dalla volontà dell’uomo) debba
semplicemente essere trovata, dichiarata, chiarita, essere cioè oggetto di discernimento. Questo è il “diritto”, lo ius, della cosa. La legge, invece, o lex, è la regola, complementare e in qualche modo attuativa della normatività [19]