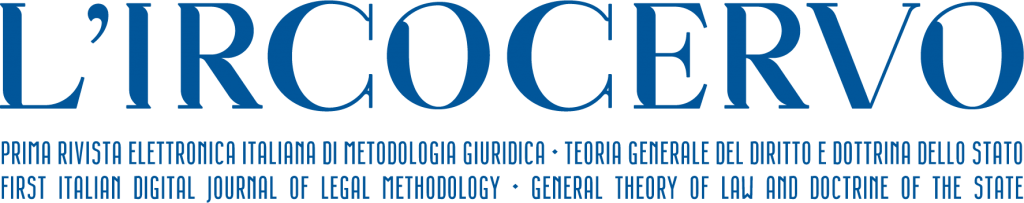LA TUTELA PENALE DELLA «DIGNITÀ UMANA»: TRA ESIGENZE DI GIUSTIZIA E DI PROTEZIONE DEL BENE GIURIDICO[1]
di Giovanni Caruso
| Scarica l’articolo > |
1. Premessa
Il problema della tutela penalistica della dignità umana esige che si chiarifichi lo stesso concetto di «dignità umana» nella sua specifica traduzione giuridico-penale, ossia sullo specchio riflesso costituito dalla repressione dei contegni che ne costituiscono la negazione; l’ordinamento italiano, in particolare, ha riformulato recentemente i delitti di schiavitù[2]. Di fronte a codesto sforzo di politica criminale, ho potuto riflettere, con rinnovato interesse e slancio critico, sui criteri in base ai quali il legislatore penale solitamente si interroga sui profili di offensività e di disvalore dei comportamenti da sottoporre alla comminatoria della sanzione penale.
Il problema ermeneutico, in effetti, ruota attorno all’esigenza di prevedere adeguate forme deontico-normative di caratterizzazione di un essenziale bene della persona, il quale, per quanto di natura spirituale e immateriale, dovrebbe costituire, nisi fallor, il nucleo cruciale di ogni politica di tutela dei beni nell’ordinamento, da quella civilistica a quella amministrativistica, da quella costituzionalistica a quella, che quivi ne occupa, di carattere penalistico. Quel problema, il quale s’è posto ai miei occhi sempre più come una vera e propria impasse teorica senza uscita, si può descrivere nei termini seguenti: a fronte del generalizzato riconoscimento del disvalore penale di comportamenti radicalmente lesivi dello statuto dignitario della persona (dai delitti di schiavitù alle manipolazioni genetiche, dai delitti contro l’identità personale a quelli relativi alle pratiche sugli embrioni), a riguardo dei quali la società moderna chiede che il giurista fornisca una pertinente lettura sub specie iuris, si posiziona un luogo comune, operante in senso contrario a cotale generalizzata rilevanza, il quale contrassegna «negativamente» le nuove forme di tutela dei beni immateriali della persona – ivi compresa la dignità umana -, in quanto sforniti di specifica concretezza ed «afferrabilità» concettuale.
Tale luogo comune si manifesta attraverso alcune ragioni di insoddisfazione per l’incapacità del giurista di apprestare una tutela penalistica contraddistinta in termini di concretezza, e si è tradotto nella particolare insistenza dedicata da parte della dottrina al concetto di «afferrabilità» del bene giuridico tutelato. In questa prospettiva, si è anche posto in rilievo come il concetto “di «afferrabilità»” della tutela, tanto caro al penalista, vada riferito “non tanto […] al bene penalmente tutelato, quanto piuttosto alla sua negazione dialettica, cioè alla lesione del bene stesso, in cui consiste la violazione penale”, poiché “nei reati contro la persona, di regola non è difficile afferrare il valore umano che la norma incriminatrice vuole proteggere; ciò che molto più difficilmente si afferra è la soglia oltre la quale, o gli elementi in presenza dei quali, siffatto valore umano può ritenersi significativamente leso”[3]. Tali difficoltà, d’altra parte, hanno legittimato le perplessità di parte della dottrina sull’opportunità dello stesso ricorso alla tutela penalistica, imponendo “di cominciare a ripensare se sia davvero opportuno, se non legittimo, continuare a mantenere l’attuale forma di tutela penale a garanzia di beni giuridici connotati da una particolare «inafferrabilità» – che contrasta con il carattere necessariamente tassativo dell’illecito penale – e nei confronti dei quali peraltro, la sanzione penale non sembra affatto sortire effetti positivi in termini di prevenzione generale”[4].
Queste posizioni di diffidenza, quando non radicale avversione, a riguardo della legittimità delle politiche d’incriminazione dei beni non caratterizzati da sensibili gradienti di «palpabilità», se, da un canto, non condivisibili nella loro genericità, da un altro canto rivelano le difficoltà incontrate dal giurista positivo, informato all’assioma del principio di sovranità, e ai suoi corollari dogmatici nell’interpretazione operativa[5], nel cimentarsi con l’indagine dialettica e an-ipotetica del concetto di dignità umana e con l’analisi dei caratteri degli atti umani di essa lesivi.
Invero, a me sembra che le ragioni dei gravi disagi esibiti in dottrina in rapporto alla tutela penalistica della «dignità umana» si possono cogliere attraverso una triplice indagine: la prima, di carattere, lato sensu, teorico-generale, induce a riflettere sull’origine culturale degli «imbarazzi» del penalista nel cimentarsi con la tutela della componente razionale, etica e spirituale, della persona; la seconda, che potrei definire «fenomenologica», concerne una riprova storica di tali difficoltà, tematizzabili analizzando le aporie in cui si è imbattuta la letteratura giuridica italiana nel delineare i profili di offensività nei delitti contro il bene «immateriale» dell’onore; la terza, che definirei «filosofico/dogmatica», sarà volta a individuare, in uno alla genesi di tale inadeguatezza, anche una possibile via d’uscita, da intraprendere abbandonando la concezione del diritto quale arsenale di controllo sociale a disposizione del Sovrano (con estromissione radicale, tipicamente moderna, dell’idea di «giustizia» dall’orizzonte del ragionamento giuridico, in generale, e penalistico, in particolare), a favore di una riflessione che sappia cogliere dialetticamente le ragioni del giusto e dell’ingiusto sia nel singolo rapporto interpersonale, sia nel complessivo contesto comunitario.
2. L’origine culturale del disagio del penalista nel delineare la tutela dei beni «immateriali» della persona.
Credo che per comprendere le origini culturali di codesta difficoltà ermeneutica se ne debbano ricercare i fondamenti giustificativi nella cifra teorica del positivismo giuridico. Per gran parte del quale[6], la “più assoluta e rigorosa obiettivazione giuridica dell’azione o contegno dell’uomo consiste nella depurazione di questo concetto da ogni elemento soggettivo, consiste nella sua più assoluta e rigorosa desoggettivazione o, come sarebbe preferibile di dire, nella sua spersonalizzazione”; sì ché “ci appare in tutta la sua più sconcertante violenza il connotato del controllo sociale, quale tematizzato in varia ma costante maniera dalla geometria legale”, e risultante “dalla combinazione di un potere effettivo, la «spada» di Bodin, le «mani libere di Hobbes», e della virtuale unificazione dei comportamenti individuali mediante la rappresentazione normativa degli stessi”[7].
Sia pure con intendimento direttamente rivolto al modo di intendere in generale l’ordinamento giuridico e la stessa fondamentale categoria della «giuridicità» secondo la scienza politica moderna, così Francesco Gentile delinea la sottile operazione mistificatoria prodotta dalla pretesa di applicare esclusivamente il sapere scientifico, e le corrispondenti categorie d’indagine, all’esperienza umana nella società civile e politica. Il medesimo ordine di critiche viene sviluppato da Mauro Ronco sul versante penalistico, laddove, nel caratterizzare – mi si passi l’ossìmoro – la spersonalizzazione della persona, osserva: la “delineazione di un sistema efficace di tutela a favore della persona, operante ai vari livelli di profondità del suo esistere concreto, costituisce la migliore risposta dell’ordinamento giuridico alle tensioni disgreganti che si manifestano nella società contemporanea”; e tuttavia, il “positivismo giuridico ha insegnato a ricavare tale concetto esclusivamente dall’estensione della tutela predisposta dalle norme del diritto positivo, al punto che persona in senso giuridico non sarebbe quella che l’esperienza concreta di ciascuno riconosce essere tale, bensì quella che l’ordinamento giuridico tratta come tale”[8].
D’altra parte, che nella radicale disaffezione per l’approfondimento del concetto di «persona» si nasconda la più generale menda della trasfigurazione fittizia nella mera «soggettività giuridica», appare chiaro ove si rifletta sulla posizione teorica di Hans Kelsen, di certo il maggior esponente del formalismo giuridico[9] del secolo scorso. Non si prestano ad equivoche edulcorazioni le parole con cui il giurista di Praga riduce l’esperienza umana rilevante per il diritto, e – con essa – la «persona», a mera qualificazione normativa: “L’unità di doveri e di diritti soggettivi, cioè l’unità delle norme giuridiche […] le quali formano una persona fisica, è data dal fatto che è il comportamento del medesimo uomo a formare il contenuto di questi diritti e doveri”, e la “cosiddetta persona fisica non è quindi un uomo, bensì l’unità personificata delle norme giuridiche che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo”. Il quale, a sua volta, non “è una realtà naturale, bensì una costruzione giuridica creata dalla scienza del diritto, un concetto ausiliario nella descrizione di fattispecie giuridicamente rilevanti […] la cosiddetta persona fisica è una persona giuridica”[10]. Oggetto delle attenzioni del diritto non sarebbe la persona nella concreta realtà del suo esistere, sempre identificata nel brano kelseniano dalla paradossale interiezione («cosiddetta»), ma la finzione astratta della scienza, il «replicante» disumanizzato disegnato dall’ordinamento «more geometrico constructo».
Per chiarificare siffatta «vaporizzazione» teorica dell’autentico profilo personalistico, etico e giuridico, della persona, mi sembra opportuno l’approfondimento di due tematiche: occorre dapprima considerare l’origine storica e razionale di tale mutato atteggiamento antropologico in via generale; si tratta, quindi, di verificare se tale atteggiamento abbia esercitato la propria influenza anche nello specifico àmbito del diritto penale.
Sotto il primo riguardo, la storiografia tradizionale[11] individua in Thomas Hobbes il precorritore della moderna scienza politica, laddove per «modernità» deve intendersi una teoria ed un pensiero slegati dalla tradizione classica aristotelico-tomista, intrecciati ai modelli matematici e geometrici caratteristici del nuovo orizzonte della conoscenza scientifica[12]. Se, dal lato storico, la modernità costituisce l’inizio di una «nuova» riflessione sull’essere personale, dal lato razionale il mutamento trova una propria puntuale legittimazione proprio nella pretesa di applicare il metodo della conoscenza scientifica alle scienze sociali, e, tra queste, al fenomeno giuridico. Va considerato, infatti, che – come ricorda Francesco Gentile[13] -, sarebbe stato proprio lo scienziato tout court, Galileo Galilei, a spingere, pur «involontariamente»[14], il filosofo inglese nell’impresa, dapprima, di estendere il metodo scientifico a tutti i campi del sapere, comprese la morale, la politica e la giurisprudenza, e quindi, servendosi di una struttura logica rigorosa, di giustificare razionalmente l’illimitatezza del potere sovrano[15]. Sì che è innegabilmente riconosciuto come, da Hobbes in avanti, il metodo scientifico sia stato applicato allo studio dei fenomeni umani, in particolare politici e sociali, con modalità tali da fondare una forma di riflessione nettamente divaricata rispetto a quelle della tradizione politica antecedente, e – come noto[16] – fondata sul presupposto «antropologico» dell’homo homini lupus, del pactum unionis et subiectionis dante vita al macroantropos statuale, la cui unica finalità, perseguita attraverso la sovrapposizione volontaristica e violenta del proprio potere sull’individuo a-nomico dello stato di natura, sarebbe stata quella di assicurare la «vita fisica» individuale contro il pericolo di una morte violenta.