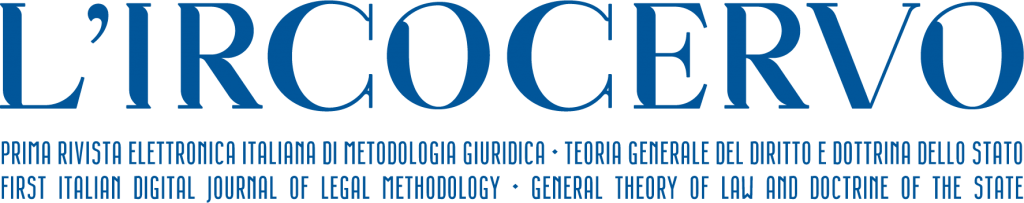L’ATTIVITÀ MEDICO/CHIRURGICA ARBITRARIA TRA “LETTERA” DELLA LEGGE E “DIMENSIONE ERMENEUTICA” DEL FATTO TIPICO
di Giovanni Caruso
Certamente, la delicatezza della questione deriva, almeno in parte, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina generale ed organica del trattamento medico, con precipuo riguardo sia alla regola del consenso del paziente, che alle implicazioni, in tema di responsabilità, di una sua violazione da parte del sanitario . Ma per lumeggiare ancòr meglio le gravi difficoltà in cui si agitano la dottrina e la giurisprudenza dominanti, è sufficiente soffermarsi su di un altro recente arresto giurisprudenziale, in cui la Suprema Corte ha proceduto all’individuazione dei profili di responsabilità penale nel caso di intervento chirurgico con esito fausto, eseguito nel pieno rispetto della lex artis, e tuttavia posto in essere in assenza del doveroso consenso informato del paziente, collocando i medesimi nell’àmbito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 590 c.p., poiché risponde “del reato di lesioni personali colpose il sanitario che, in assenza di un valido consenso dell’ammalato, abbia effettuato l’intervento terapeutico nella convinzione, per negligenza o imprudenza a lui imputabile, della esistenza del consenso”, giacché “il reato di lesioni sussiste anche quando il trattamento arbitrario eseguito a scopo terapeutico abbia esito favorevole, e la condotta del chirurgo nell’intervento sia di per sé immune da ogni addebito di colpa, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale” . Ragion per cui, i passaggi di qualche precedente giurisprudenziale, e più ancora le stesse caratteristiche del dibattito medico-legale in subiecta materia, registrano la tendenza ad una sorta di enfatizzazione in chiave giuridica della regola del consenso del paziente, “segnalando invero un distacco dall’accezione e dalla ratio di tale elemento nella cd. nuova medicina, dalla fisionomia non più «paternalistica», ma, appunto, «consensuale»” .
Come è stato correttamente osservato, “l’adesione consapevole ed informata alla prestazione del medico vale a permettere al malato di controllare le scelte terapeutiche e di assecondarle, e, al sanitario, di operare con serenità nel segno del massimo beneficio del paziente, condividendo con lui l’inevitabile rischio: secondo quella «alleanza terapeutica», che è miglior risultato delle cure” . Ma se le cadenze del dibattito medico legale e penalistico sembrano denunciare la tendenza ad una sorta di enfatizzazione in chiave giuridica della regola del consenso del paziente, ciò comporta, in parte qua, un duplice risultato: se, per un verso, l’adesione consapevole ed informata alla prestazione del medico vale a consentire al malato di controllarne le scelte terapeutiche e di assecondarle, per altro verso, quel medesimo consenso permette al sanitario di operare con serenità nel segno del massimo beneficio del paziente, condividendo con lui l’inevitabile rischio. In detta prospettiva, la regola del consenso si configura, anzitutto, come regola di rispetto della dignità della persona malata, secondo una valenza “«pregiuridica», che è di sociale solidarietà, acquisendo essa, certo, anche rilievo giuridico nel senso sia della tutela dei diritti di libertà del soggetto, sia del «trasferimento» sullo stesso del rischio insito nella prestazione”. Per cui, il rapporto tra medico e paziente si discosta dalla concezione tradizionalmente «paternalistica» ed «ippocratica», tradita dall’etimo latino di patiens – participio presente del verbo patior -, secondo la quale “paziente non è soltanto colui che sopporta la sofferenza, ma anche chi subisce passivamente l’altrui azione” . E tuttavia, se porre il consenso informato alla base del rapporto tra medico e paziente equivale a rovesciare quella che, per ragioni di comodità classificatoria, può considerarsi la concezione «tradizionale» dell’attività medica, con la conseguente e connessa implicazione che i doveri del medico vengono subordinati ai diritti del malato, e, in primis, alla sua libertà di autodeterminazione terapeutica, la stessa essenziale rilevanza del consenso medesimo non può tralignare fino al punto di costituire, come assume la giurisprudenza più rigorosa (già sul punto citata ), l’unica fonte di legittimazione dell’attività medico-chirurgica.
Tale pregiudizio, radicatosi per una disattenta lettura «decontestualizzata» dei principi informatori dell’attività medica, ha permeato talmente a fondo la mentalità del giurista, da indurlo a ripiegare, a fronte di casi in cui l’affermazione di particolari titoli di responsabilità penale (quali, ad esempio, l’omicidio preterintenzionale, o le lesioni personali dolose), avrebbe gravemente urtato la «sensibilità» giuridica e sociale, su soluzione esegetiche del tutto inappaganti, quali quella, già ricordata, del difetto dell’elemento intenzionale, pretesamente necessario ex art. 584 c.p.. Di contro, la tesi dell’«autolegittimazione» dell’attività medico-chirurgica – affermata, peraltro, dalla Cassazione anche in sede civile , e riconosciuta in passato da autorevole dottrina – conduce ad affermare che, se, da un lato, l’attività del sanitario è in sé lecita ed immune da rimprovero di rilevanza penale, dall’altro non necessita di cause scriminanti che ne neutralizzino l’antigiuridicità, in quanto non integrante già di per se stessa, se interpretata secondo un’adeguata «dimensione ermeneutica», un fatto «tipico» del reato.
Del resto, come è stato osservato da un’attenta dottrina, non può trascurarsi come la “«radicalizzazione» in chiave giuridica del principio del consenso rischi fatalmente di stravolgere questa «naturale» connotazione del rapporto tra medico e paziente, orientandola nel senso, «innaturale», di una pregiudiziale e conflittuale contrapposizione, che dissolve lo spirito del «patto» terapeutico, finendo anzi per compromettere lo stesso risultato, a questo connesso, della migliore tutela dell’interesse primario della salute” . Ma, indipendentemente da considerazioni tratte dal «contesto» interpretativo afferenti la natura dell’attività terapeutica, è proprio sul piano schiettamente giuridico, a’ sensi e per gli effetti della legge penale, che la ricordata enfatizzazione della regola del consenso può condurre a conseguenze, lato sensu, anomale, vieppiù laddove faccia difetto una specifica regolamentazione normativa, come certamente avviene in subiecta materia: di siffatta fenomenologia rappresenta banco di prova evidente la stessa surriferita equiparazione del fendente omicida all’effrazione dell’epidermide operata dal chirurgo con il proprio bisturi .
Da tale angolazione critica, dovrebbe ragionevolmente riconoscersi che l’attività medico-chirurgica trovi legittimazione, anche sul piano penale, nella sua intrinseca utilità e vantaggiosità sociale, in quanto perseguente scopi e finalità condivise e sostenute dall’ordinamento giuridico, tra le quali rientra certamente il diritto alla salute, pour cause tutelato a livello costituzionale (art. 32 Cost.): perciò, indipendentemente dall’individuazione, in essa, di ipotesi di cd. cause di giustificazione non codificate, è stato autorevolmente osservato che, quando vi “sia consenso del paziente […], e l’intervento terapeutico sia compiuto lege artis, non solo il peggioramento transitorio delle condizioni del paziente, ma anche la stessa perdita dell’integrità fisica (es. ampu tazioni, perdita di funzioni ecc.) in vista della guarigione o del miglioramento successivo, o lo stesso massimo esito infausto, per quanto dolorosi e tragici in sé, non possono essere considerati come lesioni o omicidio tipici scriminati, in quanto già carenti sotto il profilo della tipicità” .