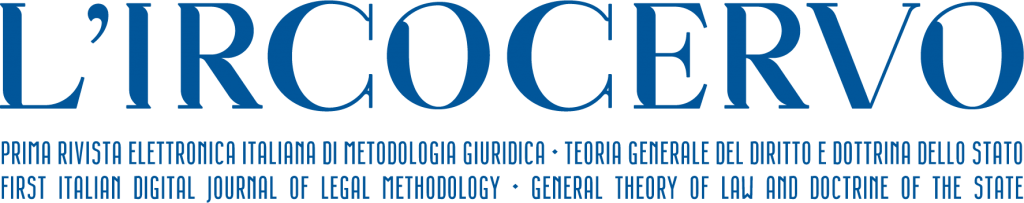L’ATTIVITÀ MEDICO/CHIRURGICA ARBITRARIA TRA “LETTERA” DELLA LEGGE E “DIMENSIONE ERMENEUTICA” DEL FATTO TIPICO
di Giovanni Caruso
Sussiste, pertanto, il delitto di omicidio preterintenzionale ove, in séguito all’intervento chirurgico illecito e in conseguenza delle lesioni personali da esso derivanti, si verifichi l’evento della morte del paziente” ; quindi, la più recente sentenza 9 marzo 2001 della IV sezione della Corte di Cassazione, in procedimento Barese: “Nel caso in cui sopravvenga la morte del malato, l’intervento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, ed in assenza di ragioni di urgenza, integra a carico del medico, se ne ricorrono le condizioni, il delitto di omicidio colposo e non quello di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), e ciò perché nella condotta del sanitario mancano gli estremi degli «atti diretti a commettere» il delitto di lesioni personali volontarie a danno del paziente” . Indipendentemente dalla soluzione concretamente prescelta dal giudice di legittimità nei due casi vitali, quanto conta in questa sede sottoporre a vaglio critico è, piuttosto, la trama esegetica posta a fondamento delle due decisioni, le quali, come è agevole comprendere, gravitano intorno al nòcciolo di una questione fondamentale, emblematicamente rappresentata da un interrogativo di grande spessore evocativo: se si possa escludere “a determinate condizioni che l’uso arbitrario del bisturi equivalga sul piano del diritto penale a un colpo di pugnale, intenzionalmente inferto” . In altri termini, il tema verrà discusso alla luce dell’apporto metodologico che si ritiene sia stato utilizzato per la soluzione della quaestio iuris, siccome emergente dalla specifica angolazione teorica dalla quale muove l’interprete della seconda sentenza, tutto inteso, come si vedrà, a farsi fedele bouche de loi secondo la cifra analitica , con la conclusiva affermazione dell’insostenibilità teorica della responsabilità preterintenzionale del medico-chirurgo alla stregua della mera considerazione di profili asetticamente sintattico-lessicali, prima facie emergenti dalla lettera della legge, con conseguente e sostanziale preterizione dei nodi «ermeneutici» (e di paradigma) che presiedono alla interazione comunicativa dei soggetti. In realtà, proprio la carenza di consapevolezza critica dell’incidenza del contesto sociale sull’opera creativa dell’interprete, non solo in sede epistemologico-procesusale, ma anche nel momento schiettamente genetico, come poc’anzi si ricordava, dell’individuazione della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza, rende la soluzione della Corte di Cassazione, pur condivisibile per i contenuti limitativi di responsabilità, affatto insoddisfacente sotto il profilo dei sentieri logici e metodici seguiti per giungere alle proprie conclusioni, in tal modo non frapponendo un argine rassicurante alla mutevolezza, pur sempre incombente, delle oscillazioni giurisprudenziali.
Per apprezzare appieno la linearità dell’argomentazione della Suprema Corte, tutta incentrata nella pretesa fedele applicazione di canoni interpretativi di stretto diritto, sia sufficiente passare in rassegna qualche brano del decisum che ci occupa: “Il problema posto oggi all’attenzione della Corte appare di non facile soluzione perché se è vero che la connotazione finalistica della condotta (la finalità terapeutica) è irrilevante – non essendo richiesto il dolo specifico per i reati di lesioni volontarie e di percosse – è altrettanto vero che la formulazione dell’articolo 584 c.p. («atti diretti a») fa propendere per la tesi […] che l’elemento soggettivo richiesto per l’omicidio preterintenzionale, quanto all’evento voluto, sia costituito dal dolo diretto intenzionale con esclusione quindi del dolo eventuale”; e ancora, d’altronde, “se così interpretata (nel senso che per l’omicidio preterintenzionale il dolo debba essere diretto o intenzionale), non sembra irragionevole la scelta del legislatore di addebitare le conseguenze non volute solo quando l’agente abbia almeno direttamente voluto l’evento attribuito a titolo di dolo […]”, per concludere che, a “parere di questo collegio il problema […] va invece riportato all’accertamento dei presupposti per ritenere l’esistenza del dolo intenzionale”, poiché “l’agente deve anticipatamente […] rappresentarsi l’esito (voluto) della sua condotta e non agire a «costo» di provocare quell’evento” . A giudizio di chi scrive, appare nitida la pretesa dell’interprete di colmare l’incertezza che il caso vitale solleva ripiegando sulla considerazione del dato letterale del quadro normativo di riferimento: l’aggettivo qualificativo «diretti», sintatticamente collegato quale attributo al sostantivo «atti», viene valutato quale elemento significativo univoco e definitivamente risolutivo di ogni nodo ermeneutico, al di là di qualsiasi ulteriore, e per ciò solo inconferente, rimando al piano della «tipicità oggettiva» dell’atto medico/chirurgico quale atto lesivo o lenitivo.
In altri termini, non discostandosi dalla basilare sistematica penalistica, dei tre profili per solito valutati onde individuare la rilevanza penale di un comportamento – fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza -, il Supremo Collegio non pone affatto in discussione i primi due, appagandosi – con tratto argomentativo invero «minimalistico» – di suffragare la propria posizione esonerativa di responsabilità per il reato più grave sulla scorta del formalistico ossequio alla lettera della legge. Questo il ragionamento del giudice: poiché la realizzazione del delitto di omicidio preterintenzionale richiede, a’ sensi dell’art. 584 c.p., la sussistenza di «atti diretti a commettere» taluni dei delitti di percosse o di lesioni, e il riferimento lessicale alla direzione dell’atto non consente altra soluzione esegetica se non quella di esigere il dolo intenzionale del delitto meno grave, l’attività terapeutica del chirurgo che incide i tessuti con il bisturi non può certamente essere sorretta (se non nei casi in cui l’intervento è esclusivamente il pretesto per infierire sul corpo del paziente) dall’imprescindibile elemento psicologico previsto per la specifica ipotesi criminosa.In proposito, si impone una prima notazione, derivante dallaconstatazione di come l’interprete, così operando, abbia radicalmente omesso di considerare il «contesto» nel quale è chiamato a decidere, disinteressandosi del «paradigma» nel quale si inserisce la propria attività interpretativa e decisoria ; tanto che è sufficiente aderire ad altra e contrapposta esegesi, altrettanto legittima e sostenibile, del solo «testo» dei riferimenti normativi rilevanti per revocare in dubbio la correttezza giuridica della soluzione adottata. La tentazione, per mera esercitazione di riscontro, è forte. Infatti, in primo luogo, si può fondatamente ritenere che la «direzione» degli atti rilevante ex art. 584 non è tale da escludere il dolo eventuale, laddove si consideri, ad esempio, che l’articolo 43 c.p., che disciplina in linea generale l’elemento psicologico del reato, al primo periodo, in sede definitoria del dolo, fa riferimento al delitto “doloso, o secondo l’intenzione”: l’ossequio formale e letterale a tale protocollo non ha mai impedito alla dottrina e alla giurisprudenza di enucleare la categoria, ad esempio, del dolo eventuale, nel quale, per definizione, fa difetto l’elemento intenzionale. In secondo luogo, sempre l’ossequio formale alle formule legislative non ha impedito alla giurisprudenza di affermare la stessa compatibilità del cosiddetto dolo eventuale con il delitto tentato ex art. 56 c.p., nonostante quest’ultimo rechi il riferimento terminologico, decisamente più «connotativo» rispetto a quello utilizzato per la fattispecie criminosa dell’omicidio preterintenzionale, agli “atti idonei, diretti in modo non equivoco” alla commissione di un delitto .
3. In realtà, sarebbe stato sforzo interpretativo molto più adeguato e redditizio sul piano della solidità delle conclusioni ermeneutiche di approdo, quello di verificare, al di là del sempre incerto crinale delle formule lessicali e definitorie del «testo» della legge, il concreto «contesto» nel cui ambito si situa l’opera creativa dell’interprete in subiecta materia, interrogandosi se, alla luce di quella che si è definita la «dimensione ermeneutica» del fatto tipico, possa tuttora reputarsi che l’atto medico/chirurgico con esito infausto, posto in essere in assenza di consenso del paziente, possa considerarsi tipico e antigiuridico, prima ancora che colpevole. E, si badi, che la modulazione ermeneutica del fatto tipico nel diritto penale sia un fenomeno tutt’altro che isolato, costituisce acquisizione pacifica sol che si ponga mente, ad esempio, all’esploratissimo settore della criminalità mafiosa, che si presenta, d’altro canto, quale banco di prova particolarmente suggestivo proprio per i forti condizionamenti di indole politico-ideologica e socio-culturale in cui si imbatte l’interprete . Sennonché, valutare il «contesto» nel quale si situa l’attività ermeneutica in tema di responsabilità medico/chirurgica significa, anzitutto, interrogarsi sul significato, non «decontestualizzato», dell’atto terapeutico, e quindi, sul rilievo che va assegnato al consenso informato del destinatario dell’attività medico/chirurgica. In altri termini, concretizzando il problema, ci si dovrà chiedere se l’atto di «resezione» cutanea del chirurgo, in assenza del previo consenso del paziente, possa equipararsi all’atto di «resezione» della cute del pluriomicida armato di pugnale che attinga con un fendente il corpo della propria vittima.A giudizio di chi scrive, si dovrà, da un lato, «contestualizzare» il significato e il valore attuali del consenso informato nell’espletamento dell’attività medico chirurgica, e, dall’altro, ridelineare, secondo quanto ci si è originariamente ripromessi, la «dimensione ermeneutica» del fatto tipico anche con riguardo allo stesso concetto di «malattia», rilevante ex art. 582 c.p.. 3.1.