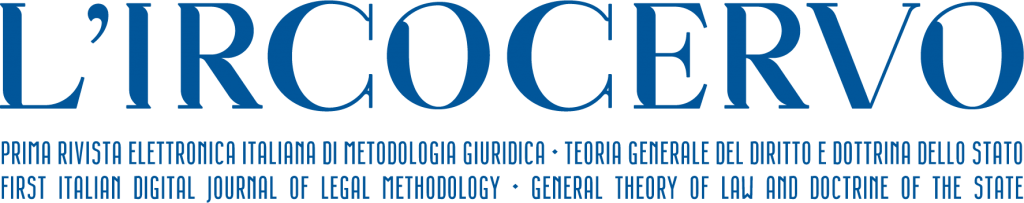SOVRANITÀ, DEMOCRAZIA, EUROPA.
RIFLESSIONI A PARTIRE DA GIUSEPPE CAPOGRASSI [1]
di Stefano Biancu
Université de Lausanne
A un popolo di schiavi, incapace di darsi altri fini che non siano quelli immediati, particolari, e finalmente egoistici dei propri bisogni quotidiani (siano essi reali o indotti), non può che corrispondere una democrazia serva, a disposizione di chi sappia meglio accarezzarne gli egoismi e i capricci. La democrazia necessita insomma di donne e uomini liberi e maturi e presuppone dunque una vasta opera educativa. Altrimenti la sovranità del popolo si trasforma in un dominio sul e contro il popolo.
Di qui, la terza tesi capograssiana che mi propongo di richiamare. Essa concerne la natura essenziale dello Stato. Si tratta dell’idea – già chiarissima fin dal Saggio del 1918 – in forza della quale lo Stato rappresenta un elemento importante della «esperienza pratica», ovvero un ambito fondamentale dell’azione umana. Agli occhi di Capograssi, lo Stato svolge cioè una essenziale funzione antropogenetica e generativa: appartiene a quelle “mediazioni” storiche che l’uomo mette in campo nel suo interminabile sforzo di giungere alla pienezza della propria umanità. Per questo Capograssi reagisce con allarme alla epocale perdita di autorevolezza e di credibilità dello Stato moderno (uno Stato che gode di un potere enorme, sconosciuto nel passato, ma che a suo giudizio vive al contempo una drammatica crisi di autorevolezza): egli è convinto che non si tratti di una perdita senza conseguenze. Se lo Stato si riduce a «giuoco e illusione» il rischio è infatti che ogni azione umana diventi tale. Per scongiurare questo pericolo occorre così – secondo Capograssi – «riconsacrare» questa forma di esperienza, per poter conseguentemente «riconsacrare tutta l’esperienza». Si tratta cioè, di fare «nostro» lo Stato: di «rispecchiare la nostra umanità nella sua sostanza». [20] Occorre insomma riscoprire lo Stato come opera profondamente umana, come istituzione di un’umanità che, attraverso le grandi opere della storia e della cultura, si umanizza: si appropria della sua stessa umanità, compiendola. Lo Stato è in questo senso un mediatore di umanità: l’uomo fa la storia (e le sue istituzioni) per fare se stesso. La storia è così il risultato del continuo sforzo dell’uomo di compiere la propria umanità e lo Stato rappresenta una produzione importante di questa azione umana nella storia. Esso – scrive Capograssi – «è una determinazione vivente e produttiva della nostra personalità considerata nella sua concretezza». [21]
Secondo il nostro autore, la considerazione scientifica non ha saputo riconoscere questa natura profondamente umana (e umanizzante) dello Stato: l’ha interpretato come prodotto di una necessità in qualche modo superiore e indifferente alla storia, dimenticando il suo essere frutto dell’azione umana: di un’azione pienamente umana, attraverso la quale l’uomo si umanizza, si fa uomo.
Qui sta dunque la grandezza dello Stato: nell’essere un prodotto e un’istituzione umana capace di produrre e di istituire sentieri di umanità. Ma qui sta anche la dichiarazione più netta e più chiara dei suoi limiti. Leggere lo Stato come tappa del cammino dell’uomo verso la pienezza della propria umanità significa infatti anche riconoscere che in esso è già iscritto il principio del suo superamento: è cioè iscritta «una realtà più alta» rispetto alle particolarità dei popoli e delle loro istituzioni statuali. Si tratta di ciò che Vico chiamava «civitas magna»: l’utopia di un mondo unito e profondamente eguale, ben oltre i vari particolarismi statali. Per questo, secondo Capograssi, ogni vera ricerca sullo Stato non può che essere «una profonda meditazione sulla sua fine»: [22] sul suo superamento. Lo Stato, in quanto istituzione della storia, non è insomma niente di assoluto. Esso è una tappa in vista di altro: in vista di un’umanità capace di adeguare pienamente la propria umanità, di essere perfettamente eguale a se stessa e di essere, dunque, eguale al suo interno: unita e in pace.
Lo Stato, in quanto mediazione della soggettività e della socialità, non è né una parola prima né una parola ultima: la parola prima è infatti l’umanità dell’uomo in quanto umanità da compiere, e che si compie attraverso le istituzioni della storia; la parola ultima è ancora una volta l’umanità dell’uomo, in quanto umanità compiuta, anche grazie allo Stato, ma comunque oltre esso. Sbaglia dunque, secondo Capograssi, chi affida troppo allo Stato, giacché esso non è niente di assoluto. Ma sbaglia anche chi nega troppo allo Stato, perché questo significa non riconoscere alcune condizioni inaggirabili della nostra umanità.
Sovranità, democrazia, Europa
Fin qui dunque, in estrema sintesi, le riflessioni di Capograssi. Evidentemente esse lasciano intravedere alcune notevoli differenze tra i problemi ai quali egli si trovava confrontato nel suo tempo rispetto ai problemi di oggi, allorché alla crisi di autorevolezza dello Stato si è aggiunta una evidente crisi di esercizio, dovuta sia ad un decentramento dei centri di potere (con un evidente primato dell’economico e del finanziario sul politico), sia ad una crisi di esercizio della democrazia, minacciata dal virus del populismo e da una mancata composizione tra la forma e il contenuto, tra la procedura e i suoi necessari presupposti. Eppure mi pare evidente che il contributo di Capograssi possa ancora oggi dare a pensare: mi propongo dunque di partire da esso per alcune riflessioni.
1. Innanzitutto la sovranità non può non appartenere al popolo. Un principio che, com’è noto, la Costituzione italiana ha recepito all’articolo 1. Conseguentemente il diritto non può che esprimere, sotto forma di norma giuridica, la volontà che emerge dall’esperienza vivente di questo popolo (Capograssi parla a questo proposito di una «esperienza giuridica» fondata sulla «esperienza comune»). [23] Il diritto non può cioè essere arbitrio: esso non è mai del tutto disponibile al sovrano (chiunque egli sia). In fondo non è del tutto disponibile neanche al popolo, nella misura in cui quest’ultimo non può tradire i presupposti reali della sua esistenza «comune». Qui sta, evidentemente, un principio antitotalitario fortissimo.
2. Ma il principio di un radicamento del diritto – e dunque dell’esercizio della sovranità – nella vita reale del popolo ha una sua ben precisa condizione di possibilità: che il popolo sia capace di ritrovare nella sua esperienza i contenuti normativi propri del diritto. Che sia cioè capace di distinguere tra diritto e capriccio, tra dovere e imposizione arbitraria, tra bisogni reali e bisogni indotti (magari dalla propaganda commerciale o politica). Per dirla con Capograssi: se la sovranità non può non essere del popolo, il popolo deve però meritarsela. Un popolo sensibile alle moine del populismo non è un popolo né autorevole, né libero.
E il populismo non è l’apice della sovranità popolare, ma una forma subdola di dominio sul popolo. Affinché l’autorità sia del popolo, il popolo deve essere autorevole.
3. Ora, questo significa almeno due cose. Innanzitutto significa che la libertà politica è necessaria, giacché senza libertà non c’è diritto, ma soltanto arbitrio: al popolo – e ad ogni individuo in esso – deve dunque essere formalmente riconosciuta la libertà (nel senso delle libertà tipiche di uno stato di diritto democratico). In secondo luogo significa però anche che la forma di questa libertà ha delle condizioni ben precise e che essa non è affatto un dato immediato che possa semplicemente essere dato per scontato. Come diceva Capograssi, la libertà non può cioè essere libertà di pensare o di non pensare: essa è certamente una condizione indispensabile del pensiero, ma – allo stesso tempo – è anche un risultato del pensiero. La politica non può, in altri termini, limitarsi a garantire la forma della libertà: deve occuparsi anche della forza di questa libertà. Pensare è certamente un diritto, ma è anche un dovere, che si deve essere messi in condizione di esercitare. In questo senso, la democrazia presuppone l’educazione: la maturazione di una diffusa capacità di pensiero.
4. Ora, in democrazia il pensiero necessita almeno di due condizioni. In primo luogo necessita di uno «spazio pubblico» in cui possa aver luogo la pubblica argomentazione. [24] Spazio pubblico neutro e laico che spetta alla politica garantire. Senza spazio pubblico non solo non c’è pensiero pubblico (nel senso, minimo, dell’opinione pubblica), ma il pensiero tout court risulta gravemente deficitario. E questo in quanto il pensiero non è mai un esercizio esclusivamente individuale e solipsistico: esso è insuperabilmente dialogico e il dialogo necessita di uno spazio di incontro. Lo diceva già Kant (in maniera quasi sorprendente): «Fino a che punto penseremmo, se non pensassimo per così dire in comunità con altri, ai quali partecipiamo i nostri pensieri ed essi a noi i loro?». [25]
5. Ma c’è ancora una seconda condizione affinché in democrazia sia possibile il pensiero. Si tratta della garanzia non soltanto di uno «spazio pubblico», ma pure di una «durata pubblica» [26] : di un dialogo non solo in estensione (tra posizioni diverse appunto, tra destra e sinistra… – si tratta sempre, non a caso, di metafore spaziali), ma pure in profondità (con il passato e con il futuro). Solo una durata pubblica può infatti favorire la maturazione di quella che Böckenförde chiama una «base pregiuridica comune»: [27] ciò che – per dirla con Capograssi – rende un insieme di individui semplicemente «coesistenti» (nello spazio) un popolo di «conviventi» nello spirito. Si tratta, in altri termini, di quell’esperienza comune che sta alla base dell’esperienza giuridica, sulla quale deve a sua volta fondarsi la norma positiva. Se dunque alla forma della libertà potrebbe teoricamente bastare uno spazio pubblico, la forza della libertà richiede anche una durata pubblica: contenuti che, giunti in eredità dalla storia, sono fondamentali per l’identità di una comunità e per la forza della sua democrazia.
6. Qui si apre però il problema – oggi esasperato – delle identità. Parlare della necessità di garantire una “durata pubblica” non significa infatti forse indulgere alla retorica delle identità? Certamente significa questo se con “durata pubblica” si intende una continuità sostanziale di contenuti: questo sarebbe fissismo e, se esasperato, fondamentalismo. Ma “durata pubblica” non è questo.
Per comprendere bene cosa sia la durata pubblica occorre richiamarsi a quel modello di socialità che l’etimologia del termine “comunità” suggerisce e sottende: la parola latina “communitas” dice infatti di un “cum-munus”, [28] di un dono comune, ricevuto (da ciascuno) e rimesso in circolo arricchito (ancora una volta da ciascuno). Questo dono – che è scambiato non solo nello spazio, ma pure nel tempo e nello scorrere delle generazioni – è certamente ciò che ci identifica: ciò che ci consente di affermare un «io» e un «noi». Ma è anche ciò che ci impedisce di interpretare l’identità come un possesso: come qualcosa da difendere contro l’esterno. Perché il cum-munus, il dono comune che ci assegna un’identità, non è un possesso, ma è piuttosto un debito che è nostro dovere restituire rimettendolo in circolo (“dovere” è peraltro uno dei significati della bella parola latina “munus”). In questo senso, la durata pubblica ci abilita a pensare, ma non lo fa “immunizzandoci” rispetto alla relazione con l’altro. Ci costringe anzi ad entrare in una logica di scambio non mercantile, nel quale ne va di quello che noi stessi siamo. Lo scambio non è cioè soltanto esterno all’identità, ma è anche interno ad essa: non c’è insomma prima l’identità – un’identità già da sempre costituita – e poi lo scambio, ma questo è costitutivo di quella (come d’altronde l’identità lo è per lo scambio). Detto altrimenti: l’identità ha natura dinamica, non statica.